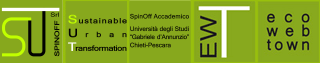Dopo aver dato conto delle difficoltà del Progetto urbano per il recupero delle periferie metropolitane (EWT17, le vele di Scampia) e per la conservazione e valorizzazione di contesti ricchi di storia (EWT 18, area archeologica centrale di Roma), stavolta lo scopo di EWT diventa più tendenzioso: confortare l’opinione di quanti ritengono che questa modalità d’intervento, in qualsiasi modo denominata, sia fattibile e talvolta anche conveniente, nonostante la maggiore complessità di gestione che impone inevitabilmente alle amministrazioni pubbliche.
Con questo numero vengono dunque presentati alcuni casi significativi di Progetti urbani in programma, realizzati o in corso di realizzazione, in contesti generalmente più abbordabili, come accade spesso nelle nostre città medie e minori. L’obiettivo è in particolare individuare quelle esperienze che possano dimostrare tangibilmente l’utilità e la fattibilità del Progetto urbano, anche se da tempo sosteniamo che è urgente una profonda revisione di questo importante strumento d’intervento a cui non vorremmo rinunciare. La revisione si rende necessaria non soltanto per ovviare i limiti esistenti, dovuti spesso a una concezione troppo formalistica e incapace di misurarsi con le condizioni più complessive di intervento su un dato contesto, ma anche per creare un elevato valore aggiunto nella trasformazione urbana, mettendo in gioco anche i temi di un auspicabile sviluppo economico e sociale.
Non diversamente dai numeri precedenti, anche stavolta per sondare il punto di vista dei protagonisti in campo EWT ha scelto di ricorrere a interviste mirate su tre questioni principali: la utilità del progetto, la sua fattibilità, e le innovazioni possibili per il futuro. Ma in questo caso le interviste sono estese ad alcuni attori indispensabili per la riuscita di un progetto urbano, anche al di fuori del cerchio ristretto di architetti, urbanisti e tecnologi. A loro dunque è stato chiesto di esprimere un proprio punto di vista sull’attualità del Progetto urbano, e la sua utilità per contrastare le derive di pratiche d’intervento puntuali, estemporanee e poco sensibili alle relazioni con la città, magari anche immediatamente cantierabili come chiedono insistentemente i costruttori, i proprietari dei suoli, molti architetti, e da qualche tempo anche la politica dei partiti e delle istituzioni di governo. Poi è stato chiesto di argomentare le ragioni che ostacolano il successo dei Progetti urbani, e le possibilità di rimuovere gli impedimenti riscontrati sulla base della propria esperienza. Infine si è rivolto l’invito a delineare le innovazioni possibili per migliorare l’efficacia dei Progetti urbani e la loro spendibilità nell’attuale congiuntura delle città italiane, in gran parte ingessata in conseguenza della Grande recessione e della prolungata crisi del mercato immobiliare.
Dalle risposte offerte alle tre questioni, e più in generale dalle esperienze sul campo documentate in questo numero di EWT, emerge un ventaglio di posizioni quanto mai variegato e contraddittorio. In primo luogo, appare abbastanza diffusa una inconsapevolezza di fondo circa la natura e il ruolo effettivo del Progetto urbano, spesso frainteso come concetto passepartout da applicare anche a progettazioni di singoli edifici. Questa inconsapevolezza purtroppo accomuna spesso sindaci e amministratori ai diversi livelli di governo del territorio. Sorprendentemente talvolta l’incomprensione si estende perfino a noti e apprezzati architetti, che sembrano sopravvalutare le virtù della progettazione per singoli episodi, senza rendersi conto della portata delle trasformazioni necessarie per contrastare processi strutturali come l’abbandono e lo spopolamento dei centri abitati delle aree interne.
È questo il caso ad esempio di gran parte dei progetti presentati al Padiglione Italia nell’ultima Biennale di Venezia, sotto la cura da Mario Cucinella. Il tema è ben scelto, il futuro dei territori interni del Paese, con l’intenzione di offrire anche all’architettura l’opportunità di contribuire alla “Strategia per le aree interne” lanciata dall’allora ministro per la Coesione territoriale Fabrizio Barca ormai più di cinque anni fa. Si consideri che In Italia le cosiddette aree interne rappresentano il 53% circa dei Comuni italiani (4.261), ospitando il 23 % della popolazione, per oltre 13,54 milioni di abitanti, con l’occupazione di un territorio che supera il 60% della superficie nazionale. Dunque un tema di grandissimo interesse, che mette giustamente alla prova l’idea che l’architettura possa costituire un significativo strumento di rilancio di territori in sofferenza (Cucinella, Arcipelago Italia, Quodlibet, 2018).
Del resto l’importante ricerca curata da Antonio De Rossi, pubblicata con il titolo “Riabitare l’Italia” e recensita da Anna Palazzo in questo EWT, fa emergere con chiarezza la complessità della posta in gioco nella Strategia per le aree interne, nel momento in cui queste non vengano più interpretate come un vuoto a perdere nel tempo, ma al contrario come una grande questione nazionale che può indurre a ribaltare le stesse immagini rappresentative del nostro Paese. Assumendo in particolare – come propone De Rita – l’Appennino come lo scheletro vitale dell’Italia, serbatoio di quell’anima contadina che tra l’altro ci ha permesso di superare a fatica le crisi economiche degli ultimi decenni (De Rita, Corriere della sera, 23.05.2019).
L’esemplificazione dell’approccio professato da Cucinella è affidata soprattutto alla sperimentazione progettuale in cinque contesti: il Casentinese; il cratere sismico di Camerino; la valle del Basento; la valle del Belice; la Barbagia. Purtroppo il contributo proposto dalla Biennale si ferma generalmente all’esercizio di progettazione di una nuova opera architettonica, che – per quanto ben congegnata – appare del tutto insufficiente per rilanciare davvero territori in condizione di grave arretratezza. Qui l’unico progetto che sembra capace di misurarsi con la scala e la complessità delle politiche di riscatto delle aree interne in condizioni di disagio è quello elaborato per la valle del Belice dal gruppo dell’università di Palermo coordinato da Maurizio Carta. Si tratta di un progetto urbano-territoriale multiscalare e multisettoriale, che mette in gioco l’intero “arcipelago eterotopico” di 14 centri minori colpiti dal terremoto del ’68 e da allora in crisi profonda. Questo progetto raccoglie tra l’altro l’eredità dell’importante investimento simbolico e materiale fatto nel passato, nell’ambito della ricostruzione guidata allora dal ministero dei Lavori pubblici e dall’indimenticabile sindaco di Gibellina Ludovico Corrao, il quale era riuscito a coinvolgere architetti e artisti di fama internazionale nell’utopia di una rinascita post-terremoto come espressione dell’incontro tra arte e architettura. Un esperimento per inciso tanto illuminato quanto purtroppo fallimentare soprattutto per le conseguenze a carico della popolazione locale, al punto da aver sconsigliato da allora e per sempre l’incontro creativo tra diverse forme di progettualità, ridimensionando la ricostruzione post-sisimica al rifare tutto acriticamente “com’era e dov’era”, e rinunciando di fatto a costruire un nuovo futuro.
Il progetto del gruppo Carta invece prevede opportunamente di completare criticamente un’opera incompiuta, il cosiddetto Teatro di Pietro Consagra a Gibellina nuova, riempiendolo di nuove funzioni urbane, opportune, credibili e finanziabili. Ma soprattutto introduce una visione al futuro per lo sviluppo locale colpevolmente assente nei piani promossi allora dal ministero: il Belice come città-territorio policentrica e reticolare, con tre strategie di sviluppo sostenibile articolate in funzione dei diversi contesti. Agricoltura e innovazione d’impresa per Gibellina e Partanna; turismo rurale per Menfi e Sambuca; patrimonio e creatività per Salemi e Poggioreale. Questa strategia rimette in gioco anche la stupefacente opera di Burri, il cretto-sudario che avvolge le macerie del terremoto a Gibellina vecchia, la più straordinaria operazione di land art mai tentata in Europa e altrove.
Insomma il progetto per il Belice nella Biennale 2018 dimostra che per fortuna qualcuno ha capito che cosa fa il progetto urbano, come si articola, e come si applica ad aree interne in condizioni di particolare criticità.
Un secondo atteggiamento che trapela dai contributi raccolti in EWT19 tende invece a sdrammatizzare il problema. Il Progetto urbano è quello che abbiamo messo all’opera nel nostro recente passato, ed è fondamentalmente un’operazione di architettura e urbanistica, che deve soltanto migliorare la propria fase attuativa con maggiore attenzione alle peculiarità del contesto locale. Gli insuccessi riscontrati vengono rimossi, oppure non hanno da insegnare molto. L’importante è ritornare piuttosto ad avere fiducia nell’utilità di questo strumento, indispensabile per creare valore aggiunto nella trasformazione urbana, opponendosi alla disseminazione di singoli interventi autoreferenziali.
Più interessanti le posizioni di quanti – ed è una terza posizione – ritengono che il Progetto urbano vada riformulato, ma senza perdere la sua natura tradizionale di strumento d’intervento sull’assetto fisico e funzionale di una determinata realtà urbana. È questo il caso ad esempio di gran parte dei progetti innovativi elaborati nell’ambito dei piani di ricostruzione dei centri danneggiati dal terremoto in Abruzzo, analizzati nel contributo di Ester Zazzero. Qui il riferimento riguarda il cratere aquilano, e in particolare l’esperienza condotta dai Comuni dell’Area omogenea 5 in collaborazione con il centro Scut dell’Ateneo di Chieti-Pescara. Questa esperienza, concordata con l’Ufficio di missione per la ricostruzione, attribuisce ai Progetti urbani il compito precipuo di innescare e diffondere i processi di messa in sicurezza del patrimonio insediativo locale, curando in particolare la predisposizione delle vie di fuga per eventuali futuri sismi.
Infine, la quarta posizione di quanti propendono per un profondo ripensamento del Progetto urbano, rilanciandone il senso e i contenuti nella prospettiva di una innovativa integrazione con i programmi di sviluppo locale. Le ricadute di questo approccio si rivolgono non soltanto al miglioramento degli assetti fisici e funzionali di un determinato contesto insediativo, ma anche all’impulso fornito allo sviluppo sostenibile dell’economia e della società locale, venendo finalmente incontro alle aspettative implicite dei sindaci. I quali come è noto hanno bisogno di migliorare la funzionalità e la qualità delle strutture fisiche delle proprie città, ma soprattutto di offrire sbocchi concreti alla pressante domanda di occupazione e di coesione della società locale. Qui lo studio per la valorizzazione del Quadrilatero di Verona coordinato da Marino Folin offre un embrionale ma illuminante esempio di come potrebbe evolvere il Progetto urbano, nel caso si facesse interprete di un programma strategico di rilancio economico, sociale, urbanistico e paesaggistico-ambientale di un centro storico che vuole sottrarsi al solo consumo turistico.
Questa via all’innovazione del Progetto urbano appare senz’altro la più interessante da praticare, anche se comporta la necessità di far convergere localmente una varietà di politiche di settore, funzionalizzate all’obiettivo dello sviluppo sostenibile condiviso dalle amministrazioni ai diversi livelli. In realtà una simile prospettiva appare fattibile soltanto quando è possibile fare ricorso a un leale e fattivo partenariato interistituzionale, meglio se assistito dalla collaborazione con istituzioni private come banche e fondazioni per lo sviluppo. Tutto ciò la rende purtroppo al momento altamente problematica, come del resto dimostrano le inquietanti vicende di ricostruzione mancata di molti territori colpiti dai sismi recenti, dall’Abruzzo all’Emilia Romagna, alle Marche, al Lazio e all’Umbria, dove ha fallito clamorosamente proprio la concertazione tra Commissario governativo, Regioni e Comuni.
Ne discendono comunque alcuni indirizzi per la possibile innovazione del Progetto urbano. Come suggerisce Fontana, il padre dei Programmi complessi in Italia, c’è da inventare una nuova governance di progetto, magari ricorrendo a una sorta di Struttura di missione per l’accompagnamento ai progetti, sul modello francese. La Struttura di missione, di impronta pubblicistica ed espressione in primo luogo della cooperazione tra Stato e Comuni con l’auspicabile coinvolgimento delle Regioni, dovrebbe farsi carico delle intese e dei patti da costruire sia con gli investitori che con gli altri attori dello sviluppo, dando sostanza al progetto che altrimenti rimane un puro disegno di forme sulla carta.
C’è poi il problema, finora largamente irrisolto, del montaggio della effettiva partecipazione “dal basso”, con procedure che consentano di aprire la costruzione del progetto urbano a interessi terzi rispetto ai promotori immobiliari e al Comune, mirando in particolare alla cattura di un consenso allargato da parte della cittadinanza. Al tempo stesso c’è da imporre procedure più trasparenti e impermeabili al malaffare. Abbiamo appreso infatti dall’esperienza che i singoli interventi di piccole dimensioni sulla città sono spesso avallati da un atteggiamento compiacente da parte dei funzionari della amministrazione comunale, conniventi con le imprese di costruzioni interessate. Invece i Progetti urbani per la loro natura e dimensioni che li caratterizzano, rinviano a intese più complicate, che spesso mettono in gioco il tornaconto occulto di alcuni autorevoli esponenti dei partiti in grado di assicurare il difficile consenso. Questi aspetti scivolosi emergono ad esempio nella recente indagine della Procura di Roma su alcuni Progetti urbani rimasti incomprensibilmente fermi a Roma da anni, fino a che non si è trovato l’equilibrio tra le diverse istanze con modalità corruttive che consentono di sbloccare finalmente i progetti.
C’è infine da prevedere un approccio flessibile e graduale per l’impostazione e attuazione dei progetti, i quali sono preferibilmente chiamati a mobilitare le disponibilità all’investimento di capitali privati aggiuntivi, trainati dalla realizzazione di opere strategiche di natura pubblica.
Il coinvolgimento dei capitali privati diventa una condizione indispensabile per raggiungere una massa critica di investimenti, all’insegna di quegli accordi pubblico-privato che dovrebbe animare l’intera strategia della trasformazione urbana governata dal progetto urbano.
Intanto che vengono delineati alcuni requisiti dell’innovazione per i nuovi Progetti urbani, affiora inevitabilmente il ricordo del modello introdotto dai Prusst alla fine del secolo scorso. L’esperienza dei Prusst è controversa ed ha suscitato allora numerose opposizioni, soprattutto da parte dell’urbanistica ortodossa che ancora sopravvive nelle pieghe più conservatrici della nostra cultura di governo. Ed è innegabile che sono stati compiuti numerosi errori, soprattutto quando i Prusst sono stati utilizzati impropriamente come grimaldello per sdoganare aree altrimenti inedificabili. Però non c’è dubbio che nella loro concezione iniziale rispondessero a molti dei requisiti che stiamo proponendo per un moderno Progetto urbano. Un’opera di natura pubblica, solitamente un’infrastruttura, funge da attivatore della trasformazione urbana. Le attese di rendita differenziale innescate dall’infrastruttura muovono i proprietari delle aree limitrofe e altri investitori privati, tutti guidati dalla strategia disegnata e gestita dalla cabina di regia pubblica, sotto forma o meno di Struttura di missione. L’accordo obbligatorio tra Stato e Comune riduce comunque i rischi di soluzioni dettate dalle convenienze locali o da altri interessi privatistici.
Rimane la vera questione di fondo del rapporto tra Piano urbanistico e Progetti, che è poi quella che ha portato ad affondare i Prusst. Più volte EWT ha messo in guardia rispetto all’inaccettabile mainstream dell’urbanistica conservatrice, che intende incardinare i Progetti nella fase preventiva di costruzione del Piano, per poi attuarli deterministicamente. Né del resto sono accettabili Progetti urbani che si accendono soltanto dove e quando maturano le condizioni per la loro ideazione e messa in opera. C’è dunque da innovare sostanzialmente questo nesso irrisolto tra Piano e Progetti, che rappresenta la chiave di volta di un nuovo modo di governare lo sviluppo della città. Altre volte abbiamo fatto riferimento al possibile potere risolutivo di una Visione guida condivisa per il futuro della città e del suo sviluppo economico e sociale, come adombrato dal sindaco Di Primio per il caso di Chieti. La visione dovrebbe fungere da quadro di coerenza flessibile ma relativamente certo, attraverso cui diventa possibile valutare l’ammissibilità dei nuovi Progetti.
Se non è la Visione guida, altre dovranno essere le soluzioni da escogitare e da mettere in opera. Ma non v’è dubbio che l’effettiva praticabilità dei futuri Progetti urbani passa in primo luogo attraverso una ridefinizione più avanzata dei loro rapporti con il Piano urbanistico comunale. E su questo nodo c’è ancora molto da lavorare per giungere a soluzioni soddisfacenti, sfuggendo alla sterile contrapposizione tra dirigismo ineffettuale del piano e occasionalità guidata dal mercato.