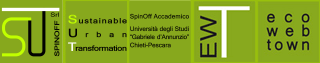Le forme imprendibili
Franco Purini
Secondo una convinzione radicata in me da molto tempo, l’Antico è un luogo concettuale duplice e contraddittorio. Per un verso esso è infatti ciò che produce il Nuovo, nel senso che, esaurendosi progressivamente i suoi valori, esso fa sì che si cerchi qualcosa che lo superi; per l’altro il Nuovo ovvero, ciò che dovrebbe oltrepassare l’Antico, si oppone radicalmente al lascito del passato, rivendicando, rispetto a questo, una genetica differenza. Ma non basta. Quando il Nuovo, o un insieme di Nuovi, vengono alla luce, l’Antico non resta quello che si pensava fosse fino ad allora, ma viene reinventato. In breve il Nuovo è una conseguenza dell’Antico, ma anche ciò che ne modifica l’aspetto e i contenuti, quasi ricreandolo ex-novo. Questa retroazione aggiorna costantemente l’idea di Antico per mezzo della Storia dell’Arte, dei mutamenti del gusto e conseguentemente dall’avvicendamento delle mode, dei conflitti ricorrenti tra il presente, il passato e il futuro, degli incroci dei saperi diversi.
Se si pensa a Roma e al suo straordinario patrimonio archeologico, per inciso divenuto un riferimento proprio per tutta l’architettura occidentale, questo insieme di contraddizioni e di ambiguità appare piuttosto vasto e complesso. L’Antico del Medioevo è diverso dalla sua rilettura nell’Umanesimo, nel Rinascimento, nel Manierismo, nel Barocco e nel Neoclassico. Le avanguardie del Novecento, quando non lo hanno rifiutato come è avvenuto nel Futurismo e nel Bauhaus gropiusiano, lo hanno interpretato in una pluralità di modi, se si torna sulle visioni della Metafisica dechirichiana, del Novecento milanese, delle varie Scuole romane - da quelle degli Anni Trenta alla Scuola di Piazza del Popolo - della Transavanguardia e dell’Arte Povera, nella quale L’Antico arretra fino all’archetipo. Negli ultimi quattro decenni l’Antico a Roma è stato ricreato almeno due volte, la prima quando i palazzi cinquecenteschi e barocchi hanno ritrovato i colori originali, chiari rispetto alla precedente tinteggiatura ocra, la seconda quando il turismo di massa ha imposto paradigmi culturali di matrice divulgativo- spettacolare. A causa di questa revisione il mistero che emanava dall’Antico, e che tanto ispirò la conoscenza di Roma di Johann Wolfgang Goethe, si è dileguato, sostituito dalla proclamata certezza che tutto può essere conosciuto, ricostruito, compreso nella sua interezza. In questo modo l’Antico è divenuto un Nuovo invecchiato e non più un universo sacro, benché dotato di confini variabili, pervaso di mito, vale a dire uno spazio dell’immaginario che è altra cosa dal pensiero scientifico e da ciò che può rivelare l’indagine storica.
Per quanto detto finora penso che il problema che si pone oggi della condizione presente e del futuro del patrimonio archeologico romano, in particolare quello dell’Area centrale dei Fori, del Campidoglio e del Palatino, è rappresentato principalmente dal considerarlo come un deposito di memorie che è possibile decifrare, anche se con qualche difficoltà. In effetti le rovine sono viste oggi come scheletri strutturali di organismi architettonici che è possibile, con gli occhi della scienza archeologica, rivedere rivestiti di muscoli e di epidermidi che li riconsegnano a noi nello loro essenza originaria. Un’essenza che il turismo di massa fa anche, da decenni, discendere da come il cinema, attraverso una nutrita serie di pellicole, ha restituito queste architetture dividendosi tra ricerca filologica, come nelle scenografie di Veniero Colasanti per il film La caduta dell’impero romano, e le suggestioni digitali de Il Gladiatore di Ridley Scott, al quale si deve la rinnovata e impetuosa riscoperta nel nuovo secolo del Colosseo.
Dal mio punto di vista la rovina è oggi molto più enigmatica di quanto non lo fosse quando George Simmel scrisse su di essa il suo famoso saggio. Il Nuovo che attualmente riscuote il maggiore seguito, cioè l’architettura tecnologica alleata dell’archiscultura - un’architettura dalla plastica esaltata così battezzata da Germano Celant - ha proiettato la sua immagine anche sull’Antico, riproponendolo come la premessa di un linguaggio del costruire performativo, sostanzialmente privo di una sua scrittura tettonica coerente, a suo modo casuale. Simile, e non è un paradosso, a quella sua versione che possiamo osservare in qualche albergo della Las Vegas venturiana e in alcune opere storiciste del Postmodernismo.
Avviandomi alla conclusione di queste brevi note credo che per ciò che concerne l’Area Archeologica Centrale occorra decidere non tanto l’eliminazione della Via dei Fori Imperiali, che rimane necessaria per la logica stessa del tracciato urbano di quella parte della città, quanto la riduzione della sua larghezza e lo svuotamento della sua base. In una parola la soluzione è un viadotto abbastanza leggero che sorvoli i resti archeologici. Ciò permetterebbe un’esperienza oggi impossibile, ovvero individuare visivamente il sistema dei recinti, accostati l’uno all’altro, i quali contraddistinguono l’impianto insediativo che ha regolato nel tempo la successione dei Fori. A corredo di questa soluzione sarà necessario realizzare alcuni servizi per i visitatori, oggi quasi del tutto assenti. Si tratta di una struttura di una certa consistenza che potrà sovrapporsi alla stazione della nuova linea metropolitana all’altezza della Velia. Tuttavia l’intervento maggiore dovrebbe essere indentificato nel distinguere il paziente e spesso illuminato lavoro degli archeologi dallo stupore affascinante di ciò che non può essere rivisto nella sua perduta finitezza - l’illusione di Sigmund Freud - ma che può volta per volta suscitare forme mai esistite, imprendibili nella loro transitorietà, metamorfiche, immerse in una condizione vitale che non può essere riprodotta, ma solo desiderata.