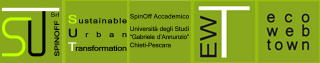1.Una realtà sempre più complessa, chiusa in piccoli recinti, frammentata, fragile e allo stesso tempo oppositiva, appare ciò che oggi caratterizza gran parte delle città e le relazioni sociali, economiche e culturali che in esse si stabiliscono e si sviluppano .
E questo avviene proprio quando si credeva che la rivoluzione digitale avrebbe semplificato e reso obsoleto gran parte dell’armamentario di regole, strumenti, consuetudini, che apparivano come trascinate dal secolo scorso.
Sembrava a portata di mano la possibilità per il sistema tecnologico-informatico-digitale di assumere decisioni con maggiore rapidità e con minori condizionamenti di quelli fino a ieri abituali. Sarebbe diventato possibile conformare gli spazi vitali in cui queste nuove opportunità avevano luogo, naturalmente quelli urbani (considerate le caratteristiche intrinseche del sistema) e poi con crescente -ma solo apparente- intensità anche quelli extra-urbani e rurali.
In realtà, le magnifiche sorti e progressive della rivoluzione tecnologica-informatica-digitale non sono state totalizzanti. All’indiscutibile aumento a scala mondiale del benessere individuale e collettivo, ha fatto da contrappunto a scala locale (un “locale” di estensione naturalmente anche molto diversa, secondo i punti di vista considerati) un acutissimo aumento della povertà, del disagio, dell’esclusione, dell’ansia, dell’instabilità per una fascia ancora importante di popolazione, anche se certamente più ristretta di quella dei decenni precedenti. Analoghi elementi distintivi hanno via via caratterizzato le diverse zone delle città.
Paradossalmente, l’enorme aumento di ricchezza circolante ha innescato profondi e violenti processi di diseguaglianza economica, nella distribuzione della ricchezza patrimoniale e del reddito fra paesi (occupy wall street è stato il movimento internazionale che più di tutti si è fatto carico di contestare quanto avveniva), fra individui e fra gruppi all’interno di una società, con l’inveramento di analoghi processi di diseguaglianze distributive sui tessuti urbani.
Negli ultimi venti/trent’anni, con l’accelerazione del processo di globalizzazione dell’economia, si sono fatti più evidenti e reali i conflitti con il sistema della coesione sociale.
“L’internazionalizzazione dei mercati di beni, servizi e capitali hanno creato uno spartiacque tra i gruppi qualificati, professionali e cosmopoliti in grado di trarne vantaggio e il resto della società. Durante questo processo, due forme di divergenza politica tendono a inasprirsi: una divergenza sul fronte dell’identità, articolata sulla nazione, sull’etnia o sulla religione; e una divergenza sul fronte del reddito, che ruota attorno alla classe sociale. I populisti derivano il loro fascino dall’una o dall’altra: quelli di destra…puntano a una politica dell’identità, mentre quelli di sinistra,… enfatizzano il divario tra ricchi e poveri.” (D. Rodrik, 1997, 2016).
E’ entrato in crisi il clima di fiducia sociale che caratterizzava gli anni precedenti.
Si percepisce nelle cronache di ogni giorno la pesante e crescente avversione per etnie e culture diverse, dovuta anche alla preoccupazione, o a vero e proprio timore, di perdere quanto si possiede o si è conquistato, sia in termini finanziari che di posizione e prestigio nella nuova competizione sociale.
La coesione sociale è entrata in crisi, ed è sempre più difficile individuare strumenti e politiche efficaci, in grado di recuperarne un senso seppur parziale, ristabilendo un equilibrio accettabile e sostenibile nel medio-lungo periodo. L’instabilità e l’incertezza minano il senso del futuro, la paura ci fa chiudere dentro mura che ci sforziamo di trasformare in recinti sicuri attraverso raffinati sistemi di protezione o anche con l’acquisto di armi, (e richiedendo di conseguenza leggi a garanzia dell’impunità in caso di loro uso). Inseguiamo facili promesse e, così, populismi e sovranismi a buon mercato diventano speranzosi porti di approdo.
In realtà, gli unici risultati sicuri sono il decadimento delle istituzioni, la perdita del senso di solidarietà, l’insorgere della paura e il conseguente arroccamento delle comunità.
Quando poi scendiamo di scala –soltanto da un punto di vista spaziale, non da quello dei rapporti sociali e economici – e cerchiamo di esplicitare meglio questa veloce disamina dei fenomeni urbani provando a immaginare ( o, ancor più, a individuare) politiche e strumenti d’intervento, un altro elemento dovrebbe essere debitamente considerato: la necessità di affrontare il tema della “paura urbana”, mettendo in atto politiche che aiutano a superarla (in genere, quelle che una volta si definivano di sinistra), e contrastando al tempo stesso quelle populiste che vogliono che la paura continui.
“Il pianeta è diventato una immensa megalopoli. Il sorpasso è del 2006: più della metà del mondo vive nelle città……Si è innescata una guerra tra poveri, tra chi vi risiedeva e i nuovi arrivati.
Si sono moltiplicati i conflitti e allontanate le possibilità d’integrazione. In molti casi, la stessa tenuta della democrazia è messa in discussione.” (Il crollo del NOI, V. Paglia, 2017)
E’ possibile fermare la deriva e invertire questa tendenza? Superare l’insicurezza e ristabilire una normale gerarchia delle responsabilità? Quali politiche sono necessarie per i singoli Paesi? Come ritornare a considerare centrale la cura del bene comune nei rapporti interpersonali e tra i diversi gruppi?
Il principio della delega generalizzata a tutti i livelli del vivere e dell’attività istituzionale non è una soluzione, non regge di fronte alla necessità di riappropriarsi della cura e gestione dell’interesse generale (categoria che contempla completa e rafforza l’attenzione al bene individuale), svolgendo attività a contatto diretto con i problemi delle persone, al fine di promuovere il cambiamento e disinnescare atteggiamenti diffusi di rabbia e di rancore (politcs of anger).
2. Un disegno di legge del 2007, elaborato dalla Commissione Rodotà, come è noto, ha individuato una nuova classificazione sostanziale dei beni pubblici.
“Si è prevista, anzitutto, una nuova fondamentale categoria, quella dei beni comuni, … (beni) a titolarità diffusa, potendo appartenere non solo a persone pubbliche, ma anche a privati. Ne fanno parte, essenzialmente, le risorse naturali, come i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; le altre zone paesaggistiche tutelate. Vi rientrano altresì, i beni archeologici, culturali, ambientali….”.
Beni “… che stanno attraversando una drammatica fase di progressiva scarsità, oggi devono poter fare riferimento su di una più forte protezione di lungo periodo da parte dell’ ordinamento giuridico… Sono beni….che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona, e sono informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità” (Commissione Rodotà – Per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici, Relazione, 14 giugno 2007).
La Commissione propone anche una nuova classificazione più puntuale dei beni pubblici propriamente detti, una ripartizione “…in tre categorie: beni ad appartenenza pubblica necessaria; beni pubblici sociali; beni fruttiferi”.
Fermiamoci alle prime due categorie.
“I beni ad appartenenza pubblica necessaria si sono definiti come beni che soddisfano interessi generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali….Si pensi, fra l’altro, alle opere destinate alla difesa, alla rete viaria stradale, autostradale e ferroviaria nazionale, ai porti e agli aeroporti di rilevanza nazionale e internazionale.
I beni pubblici sociali soddisfano esigenze della persona particolarmente rilevanti nella società dei servizi, cioè le esigenze corrispondenti ai diritti civili e sociali. Ne fanno parte, fra l’altro, le case dell’edilizia residenziale pubblica, gli ospedali, gli edifici pubblici adibiti a istituti di istruzione, le reti locali di pubblico servizio. Se ne è configurata una disciplina basata su di un vincolo di destinazione qualificato. Il vincolo di destinazione può cessare solo se venga assicurato il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati. La tutela amministrativa è affidata allo Stato e ad enti pubblici anche non territoriali.” (Commissione Rodotà….., cit.)
La Commissione Rodotà ci offre un’altra interessante e, ai nostri fini, utile ipotesi “sulla natura e sulla tassonomia dei beni pubblici contenuta nel Codice civile”.
La città, non meno del territorio (se non addirittura in misura maggiore) è indubbiamente elemento di sintesi che fonda e differenzia la società, la politica, la vita delle persone. La città accoglie e riassume la storia, l’economia, le relazioni, i modi di vita, gli scontri e le alleanze, gli sviluppi e gli arretramenti, la conoscenza e la crescita, la ricchezza e la povertà. Non vi è dubbio che sia luogo (non meno degli altri beni sopra richiamati) pienamente …”funzionale all’esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo della persona, informata al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità” (Commissione Rodotà…,cit.).
Ecco! La città come bene comune. A maggior diritto, forse, degli altri contemplati dalla Commissione Rodotà. Ma…”se l’ideologia della città come bene comune rischia di diventare uno slogan velleitario o evasivo, la produzione di “luoghi urbani come beni comuni” rappresenta una sfida concreta e ben definita per il governo della città” (Urbanistica del progetto urbano: ambiguità e ipocrisie, P.C. Palermo, 2017)
3. Quale città allora? Roma, ad esempio!
La cinematografia italiana, negli ultimi mesi, ha prodotto, quasi inseguendosi, una sequela di film che ha posto al centro delle rappresentazioni la città, spesso Roma.
Il quadro che ne esce è reale, riconoscibile e, proprio per questo, impietoso; il divenire della città sembra muoversi all’indietro, il percorso in atto è, con tutta evidenza, diretto verso il basso.
L’immagine urbana è narrata attraverso momenti di vita quotidiana, tratteggiati a tinte forti, decise, fortemente segnati da chiari e scuri. La città è una delle protagoniste (forse la prima attrice) e porta avanti la sua storia, raccontata a tratti, spesso slegata dalla trama principale.
Si tratta di una città, Roma per l’appunto, che appare un soggetto aperto a un forte -se non eccessivo- processo d’integrazione.
Ormai parte viva e partecipe di una globalizzazione (o invasione, come è vissuta in alcune periferie degradate) che evidentemente lascia poco spazio alla tradizione e alle radici locali (naturalmente, quelle romane).
Comunità diverse utilizzano a giorni alterni gli stessi spazi comuni: oggi quella cinese per esercizi a corpo libero, domani quella musulmana per officiare la comune preghiera, il giorno dopo ancora qualche altra etnia per altri usi.
Città, questa Roma, che spesso si dimentica di essere capitale d’Italia, città europea come le altre capitali, impietosa e multietnica, dominata ieri dai rumeni dai polacchi dagli albanesi, oggi dai cinesi strozzini e nuovi padroni del mondo insieme ai musulmani, con l’uso diffuso del Burqa, che costringe a porsi domande inedite (Fortunata, 2017).
Miseria e nobiltà di una visione neorealista della società che ci circonda. Si tratta peraltro di una constatazione del reale, di situazioni prese a piene mani dalla vita dei quartieri e mostrate come in un documentario, libere dell’amarezza che un occhio poco attento potrebbe voler cogliere.
Queste rappresentazioni sono immagini realistiche, di forte verismo per città iperrealiste e folli, fuori misura e brucianti, che restituiscono la quotidianità della loro povertà. Sono immagini di uno dei tanti quartieri, o di una qualunque borgata, comunque rappresentazioni di pezzi di città vestiti il minimo indispensabile e senza peli sulla lingua.
Raccontano che è necessario sporcarsi le mani nei territori brulli e aridi delle periferie vere delle nostre città (in questo caso, le periferie romane o anche gli insediamenti spontanei sorti sulle sponde del Tevere, più simili alle aree di estremo degrado e alla povertà degli slum di città del terzo e quarto mondo), dove c’è la fiera del sovraccarico, dell’urlato, del mai suggerito, periferie altre e diverse da quelle raccontate come bisognose di “rammendi” e ricuciture.
Le immagini mostrano luoghi della periferia romana, che appare così una città rappresentativa più di tutte le altre per la necessaria riflessione sul governo della città e sulle possibili ipotesi di progetto urbanistico. Ma in verità descrivono una situazione comune a tante città (di differente grandezza) e a tanti piccoli e medi centri del nostro Paese, in cui, fra le tante questioni, l'antagonismo tra chi subisce la povertà dilagante e le istituzioni si fa sempre più esacerbato.
È la vita di quartieri degradati, di palazzi, piazze, vie e spazi abbondonati dalla gestione pubblica e privi di valore per l’iniziativa privata, in cui la mixitè forzosa è fatto quotidiano non programmato, vissuta come sofferenza ineludibile, spesso con rancore.
La vita quotidiana si svolge come un romanzo popolare, il racconto di tanta "povera gente" in una periferia misera, e di esistenze sofferte che abitano in condomini estranianti (anche se quella restituita è la rappresentazione di una quotidianità, guardata - forse, meglio dire sezionata- attraverso un filtro e da un osservatorio altoborghese).
La città (peraltro, realisticamente rappresentata) diventa esempio vivente e sventurato di tante città italiane (e non solo), dove i contrasti fra le diverse zone urbane sono più forti e gli scenari più incisivi, dove l’accoglienza dello straniero è contrabbandata come fatto reale e accettato (anche se, in molti casi ormai, questa narrazione è smentita dai quotidiani accadimenti)
Contemporaneo affresco neorealista, che rimanda alle rappresentazioni cinematografiche degli anni cinquanta che seppero annunciare i profondi cambiamenti sociali ed economici delle città negli anni immediatamente successivi al dopoguerra, quelli del grande inurbamento, dello svuotamento delle campagne e del Mezzogiorno.
Immagini di baracche, di borgate, di agglomerati edilizi che davano ricovero a gruppi sociali sottoproletari e proletari, ritratto di un’umanità che, grazie a Dio!, non esiste più (degrado che oggi, purtroppo, non volendo o non essendo in grado di contrastarlo validamente, si ripresenta attraverso le immagini e la vita quotidiana di altri uomini diseredati e dispersi sulle sponde del Tevere o sotto i portici di una chiesa).
Contadini e braccianti di allora che, abbandonata l’agricoltura, divennero i primi manovali del ciclo edilizio, prima di essere immessi, i più qualificati, nel circuito della produzione edilizia o industriale.
Proletari che, divenuti ceto impiegatizio piccolo borghese o operaio specializzato, ritrovammo abitanti dei grandi casermoni dei quartieri popolari della smisurata periferia (Roma città aperta – L’onorevole Angelina - Brutti, sporchi e cattivi – Mamma Roma, I soliti ignoti e tanti altri) o nei grandi quartieri pubblici dell’ideologia progressista: “ …In Corviale, ad esempio, furono incarnate la potenza del progetto e il dramma della politica nel loro massimo dispiegamento, ultimo bastione della città del moderno contro la metropoli/periferia che avanzava dentro il massimo della conflittualità sociale. Corviale rappresenta il tentativo fallito di dare un ordine alle trasformazioni sociali, entità etica di una visione della società come comunità politica di individui-cittadini, che andava scomparendo mentre Roma diventava metropoli del consumo totale.” (Il progetto come controparte politica, M.Ilardi, 2017).
Zone urbane e manufatti edilizi (il falansterio fallito, come qualcuno ha definito Corviale) oggi citati solo come corpose e variegate rappresentazioni del degrado. (Vigne Nuove, San Basilio, Tor Bella Monaca, di nuovo Corviale, Laurentino, solo per riferirci agli esempi più noti).
D’altronde, dopo molti anni, anche se l’ambiente urbano cui si riferisce è quello di un’altra città, l’apprezzamento, non è cambiato, …”Bellino, qui sembra Bucarest” (Ovosodo, 1997). Agglomerati urbani che mettono insieme povertà, disagio, disoccupazione, mancanza di servizi.
Un’architettura (quella mostrata nei film) esagerata, citazionista, colorata, volutamente e presuntuosamente lontana dal progetto urbanistico, che appare sempre sospesa fra demolizione e promesse di riqualificazione delle architetture, dove le ferite sono rimaste, non sono state curate, anzi, con il tempo, si sono fatte più purulente. Una rappresentazione efficace di quella parte d’Italia precaria e senza futuro, sempre incerta, continuamente in bilico fra totale abbandono e impegno per un riscatto del Paese (Jeeg Robot, 2016).
Oggi, il progetto urbanistico dovrebbe misurarsi, con maggiore attendibilità ed efficacia di quanto avvenuto negli anni passati, con realtà sgangherate, spesso “di confine”, anche suggestive, ora sanguigne, ora folli, ora più malinconiche (come le vediamo restituite in questi film), con l’obiettivo di restituire un senso di libertà perduto nel degrado. Bisogna ripartire dalle nuove periferie che si saldano e assorbono piccoli e medi centri dotati di vita propria che si trasformano, velocemente, in altre periferie (perdendo i loro caratteri originari di paese).
Zone edificate mischiate a spazi aperti incolti e abbandonati, ad accampamenti di vecchi e nuovi nomadi - che tali sono diventati perché espulsi dal lavoro, dalle famiglie, dai loro paesi - che comunque vibrano, pulsano e sentono, anche se ormai appaiono abbandonate da qualsiasi politica d’intervento sia d’iniziativa centrale sia di livello locale.
All’opposto di quanto era avvenuto negli anni passati, quando le politiche urbanistiche ( come del resto il piano regolatore) ritenevano che bastasse creare nuove centralità nelle aree periferiche dei grandi centri urbani, (molto spesso, al progetto non faceva seguito la realizzazione) “…causando una serie di insuccessi ed effetti perversi ….per la mancanza di efficaci strategie selettive, capaci di guidare e sostenere il cambiamento in forme necessariamente graduali” (Urbanistica del progetto urbano, P.C. Palermo, cit).
Ora la situazione è caratterizzata da molteplici aspetti in negativo: un’incerta gestione politica dei meccanismi di integrazione sociale; l’incapacità di impostare un intervento politico propositivo; la difficoltà di elaborare una seria posizione culturale in grado di comprendere i sentimenti di paura, di distacco ed avversione percepiti dal cittadino; di spiegargli e, in qualche modo, spingerlo a comprendere e accettare quanto sta avvenendo, con il proposito di liberarlo dalla paura e dal rifiuto. Sembra invece di assistere al consolidarsi di un marcato processo di emarginazione, in termini di degrado edilizio e di capacità di offerta di servizi, che va procedendo dalle zone esterne verso quelle centrali delle città (con la prospettiva di una tendenziale periferizzazione del centro).
E’ come se si fosse invertito il percorso, non più dal centro verso la periferia, ma dalla periferia verso il centro, anche se il processo di continuo allargamento dell’edificato e di consumo di suolo non si è mai arrestato.
E’ venuta a mancare negli ultimi anni la pur minima capacità di elaborare politiche di governo delle dinamiche urbane, come invece era avvenuto dai primi anni novanta, nonostante mille difficoltà e con chiari e scuri non sempre del tutto inevitabili, sia a livello comunitario sia di governo nazionale e locale.
Si era trattato già allora di affrontare il tema “…dell’urbanistica italiana come materia che conforma i suoli, ne disciplina l’utilizzo, ma non si occupa del “governo” o della “gestione” nel tempo delle trasformazioni urbane…. ( e di) come compensare il plusvalore con le esigenze della città pubblica? E’ questo il tema-chiave dell’urbanistica moderna (ora come allora!), che stenta a trovare soluzioni di sistema……Il plusvalore catturato dalla PA attraverso gli oneri di costruzione della L. 10/77 non è più sufficiente,……le nuove frontiere della rigenerazione richiedono ben di più;…….è l’edificabilità riconosciuta che misura il quantum di dotazioni territoriali necessarie alla riqualificazione degli ambiti individuati. (Il progetto urbano. La visione del giurista, P. Urbani, 2017).
La caparbietà con cui in quegli anni si erano misurati Amministrazione centrale e Comuni (sin dalla stagione caratterizzata dai “nuovi sindaci”) nel porre la questione del rinnovamento urbano al centro delle politiche d’intervento, era il sintomo più evidente di una cultura che aveva ben compreso l’importanza delle città come bene comune d’interesse generale.
Al riaffermarsi della questione urbana, si era risposto con un’attività che in un arco temporale più che decennale, aveva dato vita a numerosi programmi di riqualificazione urbana, territoriale e infrastrutturale, ispirati dalla convinzione che sviluppo economico e sviluppo territoriale fossero inscindibili. Oggi invece prevale il disinteresse non solo da parte di chi guarda da lontano con occhio distante e distratto (se non proprio con chiaro fastidio e mal sopportazione) dai quartieri e dalle aree urbane che ancora oppongono una qualche resistenza al degrado dilagante, ma anche, più sorprendentemente. da parte di chi quei quartieri li abita e li soffre giorno per giorno.
Quartieri dimenticati (sarebbe meglio denominarle aree edificate, perché del quartiere hanno perso il carattere), guardati come giganteschi corpi sudati, in una giornata di caldo estivo con la fatica giornaliera di vivere una vita indifferente ai più, “che non s’incula nessuno!”, dice Fortunata nell’omonimo film (Fortunata, 2017).
Periferie assolate quanto misere e provvisorie, un ambiente dove il lavoro è poco e non offre garanzie, dove non ci sono grandi bellezze (ma neanche piccole e medie), luoghi oscuri dell’hinterland romano (Non essere cattivo, 2016).
Insiemi di palazzi insignificanti, se non fosse per la loro invasività fisica, che scorrono quando viaggi sulle linee degli autobus regionali o sulle lente ferrovie locali mentre s’inseguono i cartelli con le scritte delle località attraversate (Sole Cuore Amore, 2017); o quando sono ripresi dalle telecamere di qualche televisione d’inchiesta, che insieme ai palazzi inquadra, con mal riposto gusto estetico, un corso d’acqua o una marana trasformata in fogna a cielo aperto o in discarica abusiva.
Sono i quartieri, le zone urbane, le aree caratterizzate da un misto di edificazione e ruralità, entrambe in stato di forte degrado, su cui sarebbe prioritario intervenire con progetti di rivitalizzazione economica, di riequilibrio sociale (con particolare attenzione ai profili d’integrazione), di miglioramento culturale, di adeguamento dei servizi sociali, di realizzazioni infrastrutturali, di rigenerazione urbanistica. Altrimenti non si comprende come la città spontanea, abbandonata a sé stessa, potrebbe superare le sue pesanti criticità. Realtà urbane delle cui condizioni di assetto (e di possibile sviluppo?) ormai conosciamo ben poco, e che dovrebbero ritornare ad essere oggetto d’indagine, con sistemi interpretativi il più possibile attendibili – anche se necessariamente speditivi – della condizione abitativa complessiva (economica, sociale ambientale, edilizia). L’esito potrebbe essere l’individuazione di situazioni “tipo”, quali contenitori di informazioni utili per costruire quadri predittivi in circostanze analoghe.
Quartieri abitati dai dimenticati e dagli invisibili (40 mila solo a Roma, dispersi fra le vie e i palazzi della periferia devastata), un nuovo e, per molti aspetti, diverso sotto-proletariato, privo dell’antica omogeneità sociale che lo aveva caratterizzato in anni che appaiono lontanissimi. Quartieri e vecchie borgate, una volta “…lontane dal centro, aree in cui la gente venne deportata durante il governatorato per far spazio alla nuova urbanizzazione…posti che al netto delle difficoltà e disservizi fanno parte integrale di Roma. Sono Roma” (L’alba delle borgate).
“A Roma c’erano centomila baraccati. Ma oggi il tessuto sociale è ancora più lacerato e complesso. La periferia è divenuta un agglomerato di quartieri, dove si è perso quel senso di comunità che nelle baracche ancora c’era….La questione delle periferie è la questione centrale dell’età contemporanea”. (Il crollo del Noi, V. Paglia, 2017).
Luoghi espressione d’integrazioni sociali mancate o, comunque, dagli esiti molto incerti, non solo fra gli italiani e le altre etnie (gli “altri”, quelli che vengono da fuori), ma fra le stesse diverse etnie presenti nei luoghi che, ognuna rispetto alle altre, manifestano gradi di chiusura assai marcati soprattutto da parte delle seconde e terze generazioni, quasi che il recupero delle proprie radici e tradizioni si traduca in isolamento e demarcazione delle distanze fra le diverse popolazioni.
Questo comportamento ormai si va affermando presso le diverse etnie culturali e religiose, e non caratterizza più soltanto le comunità cinesi, notoriamente impermeabili a relazioni con altri gruppi sociali, e propense a consolidare questo loro carattere isolazionista con la conquista fisica di pezzi di città trasformati in Chinatown.
Dai più attenti e sensibili autori cinematografici ci sono offerte non solo immagini di quartieri e zone urbane oggetto di possibili e auspicabili progetti urbanistici, ma anche interi corpi a tema, organismi fortemente complessi nel loro insieme, esito di sommatorie di elementi diversi, sezionabili, indagabili e progettabili anche per parti separate, con il rischio però di perdere per questa via la ricchezza lo stimolo e l’inventiva progettuale che sono sollecitati dalle diversità che contengono.
Il GRA, ad esempio. Il Grande Raccordo Anulare di Roma è la più estesa autostrada urbana d’Italia, lunga circa 70 km. Il Raccordo potrebbe essere il più interessante spazio urbano da esplorare e da riprogettare, coinvolgendo tra l’altro molteplici scuole di architettura e urbanistica. Certamente, ma non solo. Perché il Raccordo è la più importante infrastruttura strategica nella vita e nell’organizzazione della città, ma al tempo stesso elemento fondamentale e imprescindibile del sistema della logistica e dei trasporti urbani e nazionali. Inoltre, dal punto di vista paesaggistico, ma anche urbanistico, edilizio e ambientale, appare uno straordinario banco di prova per sperimentare una complessa iniziativa di governo del territorio ( coinvolgendo Stato, Regione, Città metropolitana, Comune e privati interessati) che pone al centro un bene di appartenenza pubblica necessaria.
Del GRA è stata fatta una splendida narrazione come cinema del reale. Le inquadrature si muovono, senza differenza di luogo e di tempo, fra palazzi di periferia mischiati a simulacri di “palazzine romane” - esito di processi di autocostruzione vecchi di decenni o di più recente realizzazione, spesso frutto di un abusivismo non sanato o da sempre in attesa di una regolare approvazione comunale - affacciati su campi con pecore che brucano indifferenti all’incessante traffico di uomini e mezzi che scorre loro accanto, nastro di ricucitura di antiche borgate con nuove edificazioni (Sacro G.R.A., 2013).
La presenza simultanea non è una scelta reciproca, la differente porzione di spazio utilizzato è costrizione e insieme abitudine, come lo sono tanti altri spazi di una Roma che è insieme periferica e centripeta. Un percorso fra situazioni e paesaggi urbani eterogenei, diversi l’uno dagli altri; spazi che sono ricuciti e racchiusi dentro un cerchio che tutto collega, riconducendo l’insieme variegato a un percorso unitario. Una struttura fisica imponente, fatta di raccordi, bretelle, passi e sottopassi, vie complanari che ricomprendono, fra i propri rami, zone residenziali e aree rurali, edifici direzionali e centri commerciali, strettamente radicati, avvinti a quel territorio.
Poco meno di trent’anni fa, i Ministri dei lavori pubblici e dell’ambiente furono salvati a stento dagli stradini e dalle forze dell’ordine quando si erano recati in una zona ai bordi del Raccordo, occupata da “ lampadaristi” (proprietari dei manufatti abusivi adibiti a negozi di lampadari) e altri commercianti e residenti locali, sicuri che li avrebbero convinti a lasciare le aree edificate abusivamente per far posto all’allargamento del Raccordo a tre corsie.
Non se ne fece nulla! Fu impossibile spostarli da altre parti, a dimostrazione della forza politica delle occupazioni abusive.
I due Ministri furono salvati a stento dagli stradini e dalle forze dell’ordine dal tentativo di aggressione fisica da parte degli abusivi, con solo qualche danno per i soccorritori.
Fu più semplice spostare il percorso del Grande Raccordo Anulare (in quel caso, di “grande” aveva ben poco), facendogli compiere un by-pass di aggiramento dell’area occupata.
Così, il GRA disegna il confine riconosciuto della città (non solo quello delle tariffe dei taxi), tra il dentro e il fuori, tra la città edificata e una campagna emarginata e privata dei caratteri distintivi, fonte di produzione agricola marginale.
E ancora, le strade, veri mondi reali, attorno a cui si sfalda e si riaggrega la periferia romana (e di mille altre città!), disegnano uno spazio geografico sottoutilizzato (o male utilizzato) e inespresso, e ci restituiscono soltanto l’avverarsi di un viaggio sempre uguale proiettato su un’area metropolitana grande due ore.
Quale progetto urbano (o “metropolitano”?) per queste realtà? In che modo il progetto urbano può rispondere alle necessità della trasformazione? Come individuare condizioni migliori di quelle esistenti per questo groviglio di strade/autobus treni/ metropolitane banchine/stazioni viaggi/ ritardi lavoro/esistenze spese a bordo di mezzi pubblici? Quale assetto dei poteri, quale organizzazione istituzionale, quale criterio di rappresentatività possono rispondere a questa dispersione urbana e territoriale, sovraccarica di edilizia frantumata e abitata da un nuovo sottoproletariato urbano molto spesso in cerca di occupazione o già estromesso dal settore produttivo (e in profonda crisi identitaria) che popola questi spazi, come anche i vecchi paesi trasformati in periferia metropolitana della grande città? ( Cuore Sole Amore, 2017).
Il crudo realismo dai registi contemporanei ci riporta, più di qualunque analisi sul campo, agli ambienti costruiti dove oggi sarebbe veramente necessario intervenire con la realizzazione di importanti progetti urbani.
Ma quale progetto? Ha ragione Ilardi. “Oggi per tenere insieme una città, al posto della composizione architettonica e della pianificazione, ……si teorizzano la paura, l’instabilità, la insicurezza, l’emergenza e allora s’innalzano muri, si installano cancelli, si recintano spazi, si assumono guardie private. Tutto questo non vuol dire che siamo di fronte alla fine del progetto, o che il progetto sia ormai diventato solo business sottomesso ai profitti del primo ‘palazzinaro’ che lo finanzia……(ma che il progetto) non può non definire infatti il suo percorso dentro il ‘politico’ metropolitano, che è violenza, disordine, sconnessione……(perché) il conflitto è costitutivo dell’esperienza metropolitana ed è irrisolvibile. Il progetto, dunque, non può essere un dispositivo creato dalla ragione una volta per tutte, ma un processo che ha in sé costitutivamente il concreto non razionale e, di conseguenza, la possibilità sempre presente della distruzione delle sue premesse e del suo fondamento…… L’interlocutore diretto del progetto è allora il livello del potere…… La stessa crisi della rappresentanza, costringe oggi il progetto a questa sfida, e cioè a produrre decisione politica sul territorio e dentro le sue opposizioni reali: tra forme di rappresentabilità e disordine sociale, dimensione collettiva e anarchia architettonica, diritto al lavoro e diritto al consumo, agire nella rete e vivere sulla strada, città senza luoghi e quartieri blindati.” (Il progetto come controparte politica, M. Ilardi, 2017).
Disagio sociale, periferie degradate, etnie rifiutate, centri sociali e parrocchie tra il politicamente corretto e l’oltranzismo fideistico, gruppi sociali arroccati a difesa, proletarizzazione del ceto medio e emarginazione di vaste aree urbane perdita d’identità della città, luoghi e pezzi di società privi di un progetto e sconosciuti alla politica, soprattutto di sinistra. (Cuori puri, 2017). Realtà urbane che sfuggono “ad una identificazione morfologica o topografica, e appartengono invece ad una dimensione sociologica e politica”. (Il progetto…, U. Cao, cit.)
L’anno scorso, in sede di discussione della legge di bilancio, il Governo si è posto l’obiettivo di andare “oltre il PIL” e ha inserito il benessere collettivo nella programmazione economica (L.n.163/2016). Un apposito Comitato ha selezionato 12 indicatori di benessere equo e sostenibile.
L’ultimo degli indicatori individuati (e non per importanza relativa!) è l’Indice di abusivismo edilizio (in attesa del Consumo di suolo) che “…cattura il grado di sfruttamento del suolo e il degrado del paesaggio e costituisce un'approssimazione del fenomeno del consumo di suolo l'indicatore che il Comitato avrebbe voluto includere nella lista…. …Si propone, pertanto, "l'abusivismo edilizio" in via temporanea, in attesa di poter adottare il "consumo di suolo" quando i dati saranno di qualità adeguata.” (Relazione finale del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, Roma 2017). Se il consumo di suolo (o già da oggi, l’indice di abusivismo) potesse davvero dare conto non soltanto del dato fisico ma anche di situazioni dove le marginalità confluiscono, ed essere letto con gli altri indicatori dell’aumento delle distanze sociali e della povertà assoluta, si potrebbe ben evidenziare come il tema delle periferie e dei conseguenti progetti d’intervento rappresenti l’aspetto più pressante della questione urbana italiana. Questione fortemente aggravata, come spesso avviene, dalle distorsioni temporali dovute alle fluttuazioni congiunturali del mercato fondiario e immobiliare che, da parecchi anni, vive un momento di particolare debolezza, con un ciclo particolarmente negativo sia nell’intensità sia nella durata.
Quale livello anche minimo di qualità residenziale (edilizia e di servizi) è possibile definire nelle circostanze date? Con quali costi generali e a carico di chi imputare la differenza fra qualità minima e capacità di pagarne il mantenimento nel tempo? Sono solo alcune delle domande possibili. Un vasto processo di risistemazione ortopedica della città, progetti di profondo risanamento urbano, altro che rammendo delle periferie, lì dove, molto spesso, “cosa pubblica e cosa di nessuno sono la stessa cosa”. (Il giorno del Giudizio, S.Sanna)
4. Roma è anche il centro di un sistema territoriale, l’Italia centrale, ben connessa con il resto del Paese, che la mobilità ha rimesso pienamente in gioco, e non solo per il cambiamento che investe il pendolarismo lavorativo (situazioni simili, naturalmente, riguardano altre grandi città metropolitane del Paese e le molte conurbazioni presenti in altre zone del Centro, del Nord e anche, se pur in maniera meno marcata, del Sud e delle Isole). Verso Sud, l’alta velocità va oltre Napoli fino a Salerno (e fra qualche anno, a Bari). Verso nord a Firenze e la pianura Padana.
L’Autostrada dei Parchi (A24 e 25), attraverso l’Abruzzo, arriva a Pescara dove intercetta il corridoio adriatico e a L’Aquila, città in corso di avanzata ricostruzione (la prospettiva di una nuova città, ricostruita da strutture a partecipazione pubblica, a un’ora da Roma per le esigenze residenziali di una parte dei suoi abitanti, era qualcosa di più che una semplice ipotesi all’ordine del giorno dopo il terremoto del 2009). Altre autostrade e ferrovie locali estendono l’area di Roma fino a ricomprendere, con una forte mobilità, Nettuno a sud e Civitavecchia a nord; Fiumicino e molti altri comuni della costa sono già da qualche tempo comuni satelliti.
Come per il sistema territoriale centrale, anche in altre aree del Paese e dell’Europa, si sono andate via via componendo nuove formazioni geografiche, economiche e sociali, sistemi innovativi il cui sviluppo è determinato dall’intreccio virtuoso d’infrastrutture, poli universitari, centri formativi, località turistiche, strutture produttive di nuova generazione ed ecosostenibili, con particolare riguardo al settore agricolo.
Le città, quelle grandi, ma anche quelle medie e piccole, hanno superato le fasi in cui la gerarchia era determinata dalla quantità di popolazione o dalla presenza di opifici industriali o dei palazzi del potere (bastava la sede della prefettura e del tribunale).
La strategicità di questi nuovi sistemi è affidata alla capacità di sviluppare relazioni, di accogliere e generare flussi di persone di merci d’informazioni, di saper creare cultura (fondamentale il ruolo di università, musei, Street art e spazi per residenze di artisti per riqualificare aree degradate), di essere parte di una rete di alleanze in grado di muoversi a una scala molto più vasta di quella municipale.
E però, a fronte dell’acquisizione ormai pacifica di una considerazione della città che va ben oltre il dato dei confini e della mera rappresentanza amministrativa, la nostra cultura politica e la nostra organizzazione istituzionale - nonostante sforzi e tentativi in senso opposto di cui si dirà più avanti - sono ancora disegnate su una divisione di ruoli, competenze e poteri fra soggetti locali. Nessun raggruppamento, nessuna unione di comuni è riuscita a scalfire la voglia di localismo.
Anche con la soppressione delle province (preferita a una profonda riconsiderazione, forse più necessaria, dei poteri e dell’assetto regionale) e la costituzione delle città metropolitane (di cui si è discusso per trent’anni, per poi approvare un testo di riforma costituzionale priva di una benché minima forza applicativa in grado di disarticolare, almeno per quelle sole realtà territoriali, con tutto il loro seguito di capacità economica e imprenditoriale, l’esasperato localismo nazionale), non si è avviato un significativo processo di riorganizzazione degli attuali assetti istituzionali.
Tanto più quando, come più sopra richiamato, nei più importanti paesi europei (e non solo), almeno le principali città di livello nazionale hanno assunto da parecchi anni una visione strategica del loro sviluppo, costituendosi come un sistema globale di reti, che le pone al centro di una riarticolazione della governance multilivello dalla scala locale a quella europea, e hanno abbandonato, con sempre maggiore determinazione, l’assetto che le vedeva rivestire il semplice e improduttivo ruolo di destinatarie di politiche centrali distributive (da quelle fiscali a quelle per l’assistenza).
L’operare in una visione strategica costringerebbe le nostre città a superare la condizione duale tipica della nostra cultura giuridica, così come di quella politica ed economica e, soprattutto, amministrativa (cui si è conformata, come altra faccia dell’amministrazione, quella della disciplina dell’assetto territoriale con caratteri quasi esclusivamente conformativi e regolativi).
E’ un approccio che, nella maggior parte dei casi, affronta e costringe le questioni da trattare nel rapporto fra due soli soggetti. E questo è vero sia nei procedimenti fra amministrazione pubblica (che interviene di solito nel ruolo di unica interprete dell’interesse generale, soggetto sovraordinato che detta le regole) e privato cittadino (cui non è richiesta alcuna iniziativa propositiva, ritenuta speculativa e quindi dannosa a prescindere, mentre in un processo strategico, lo stesso cittadino sarebbe definito quale “attore” della scena); sia nell’instaurarsi dei rapporti fra privati nella forma del contratto.
“Scambi leali (e non sleali né ineguali) sono la base dell’urbanistica contrattata, dove il contratto è il luogo d’incontro tra la volontà pubblica e quella privata, per la quale la partecipazione pubblica può fungere da arbitro imparziale della trasformazione”( Progetto urbano…P. Urbani, op.cit.)
La maggior parte dei programmi e delle iniziative proposte negli anni passati ha tentato di importare nelle politiche urbane e in quelle di governo del territorio una visione strategica (a cui prima si faceva cenno), con modi partecipativi e d’intervento a maglie larghe, con l’obiettivo esplicito del coinvolgimento dei molti attori presenti sulla scena urbana, anche in forme non usuali.
“La competitività di una nazione dipende essenzialmente dalla capacità delle aree urbane di favorire le attività economiche e di offrire le migliori condizioni di vita dei cittadini….Il vecchio piano regolatore, che traccia percorsi stradali e disegna piazze e isolati, non basta più; deve essere sostituito da un metodo di raccordo tra le varie potestà pubbliche che si occupano del (o che hanno comunque ricadute sul) funzionamento città, intesa come una macchina che offre servizi alla popolazione. Gestire la complessità, dalla pianificazione e gestione territoriale al ciclo energetico, dal trasporto delle merci alla mobilità delle persone, dallo smaltimento dei rifiuti al controllo dei consumi degli edifici, fino alla fruizione del patrimonio culturale, rappresenta quindi il metodo per la creazione di un sistema urbano intelligente e sostenibile”. (Profili funzionali dell’urbanistica – Introduzione alla ristampa, Paolo Stella Richter, 2016)
“Le pratiche lineari della pianificazione non sono trasferibili nei territori urbani in mutazione. In essi, l’operatore pubblico deve svolgere un ruolo più ampio di coordinamento di progetti, la cui natura e temporalità non dipendono dalla sua sola abilità. Egli deve farsi carico della progettazione generale a lungo termine, adattandosi con continuità all’evoluzione del contesto politico, economico, tecnico e finanziario. Ciò richiede di agire con metodi orientati al lavoro in al partenariato, con altri soggetti amministrativi ed economici, in condizioni di pari dignità di ruoli; di sopperire con montaggi giuridici inediti alle mancanze del quadro regolamentare. La riflessione urbanistica a grande scala, negli spazi vuoti della dispersione insediativa o nel rinnovamento del tessuto urbano esistente, è multidimensionale: si sviluppa nel tempo lungo e deve definire le condizioni dei processi evolutivi e cumulativi di trasformazione. La progettazione urbana si definisce progressivamente, nel corso di un lungo processo, dal quale siamo ancora lontani dall’aver esplorato a sufficienza le complessità concettuali e operative. Questo processo nega solide egemonie, tantomeno a carattere tecnocratico, poiché riunisce numerosi soggetti: le collettività locali, le istituzioni pubbliche presenti alle diverse scale territoriali, gli attori economici e sociali, gli esperti di differenti ambiti tecnici. Lo spazio fisico prodotto dall’interazione di questi soggetti, se concepito come opera collettiva e condivisa (che agisce su un bene comune), è ciò che definiamo progetto di territorio. Questi cambiamenti di scala e di livello di complessità segnano il passaggio da un sistema di riferimento, quello della singola città, ad un altro, quello della conurbazione metropolitana ovvero di entità geografiche ancora più ampie. E’ anche il passaggio da un sistema di riferimento sociale, quello del cittadino abitante in un dato comune, a quello di popolazioni differenziate sempre più mobili in spazi dilatati e frammentati da molteplici polarità”. ( Dieci anni di governo delle complessità territoriali – Dalle città ai territori urbani: temi e prospettive per un’azione pubblica multilivello – Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti, Gaetano Fontana, 2006).
Rappresentanti politici e illustri accademici - da posizioni regressive che trovano la loro tranquillità in sottolineature verbali di processi di partecipazione democratica (personaggi da sempre dotati di invidiabile retorica comunicativa e di grande capacità di ascolto da parte dei media) - accusarono quelle iniziative di essere parte di un processo di controriforma.
“I programmi complessi, con tutti i loro limiti, … sperimentarono forme d’intervento che, muovendosi tra progettazione dello spazio fisico e pianificazione dello sviluppo locale, ….costituirono le basi di quel processo definito di contrattualizzazione dei rapporti tra Amministrazioni pubbliche e tra queste e i privati. Un processo che incentivò il ricorso a un linguaggio tecnico condiviso, ad analisi quantitative, a sistemi di verifica dei risultati degli accordi e degli impegni presi fra le parti, una domanda di valutazione e una valutazione comprensibile e utilizzabile dalla politica…..
Si trattò di un processo a forte valenza sperimentale che consentì la produzione di buone pratiche a elevato grado di innovatività. Fu dato l’avvio alla cooperazione, alla partecipazione, al partenariato, ad una inusitata attitudine a fare sistema, un primo esempio di quello che era definito Stato minimo”. (Dieci anni di governo …op.cit.)
Ciascun attore era invitato a partecipare a un gioco che si costruiva strada facendo, di cui non erano predefinite tutte le regole, le fasi di svolgimento, l’inizio e la fine del gioco stesso; non se ne conoscevano neanche tutti gli elementi in campo.
La costruzione di progetti a scala urbana o territoriale (da Urban alle STU, dai Prusst a Sistema, dai Progetti di territorio – Territori snodo a tutti gli altri programmi di quella stagione) richiedeva che al processo di definizione partecipassero molti soggetti (in qualità, appunto, di attori).
Tutte le iniziative elaborate in quegli anni proponevano la costruzione di una nuova visione strategica dello spazio urbano e dello sviluppo territoriale, anche in considerazione di quanto stava avvenendo negli altri paesi europei.
Attenti cultori della materia, in completo disaccordo con quanto dagli stessi sostenuto qualche anno fa, più recentemente hanno invece osservato che “…I risultati sono stati modesti… gli esiti sono stati spesso parziali o insoddisfacenti perché la difficoltà non sta nei principi, ma negli ostacoli concreti alla loro attuazione….Pensare per obiettivi sembra un’innovazione auspicabile, ma il compito non può essere affidato al tecnocrate (che verrebbe a svolgere un ruolo vicario della politica, privo di legittimazione), né solo alla partecipazione spontanea dal basso. La politica, peraltro, è spesso riluttante ad assumere impegni precisi e trasparenti… Perciò è serio il rischio di uno scarto fra intenzioni e risultati… L’ambizione era garantire grandi innovazioni concettuali e tecniche…L’esito più comune è stato una retorica superficiale e ben presto ripetitiva… Se di visioni al futuro si è trattato, è mancata ogni innovazione effettiva nel rapporto con gli strumenti e le azioni ”( Urbanistica del progetto…P.C. Palermo, cit.)
Da un punto di vista assolutamente di parte, non credo che quei programmi nazionali o le iniziative avviate con la Commissione europea siano stati così irrilevanti e/o dannosi come sinteticamente riportato. Oltre a quanto ho già detto di quella stagione, essi hanno contribuito alla diffusione di un linguaggio comune e rappresentato un sicuro fattore di crescita dei settori e delle competenze tecniche d’innumerevoli amministrazioni pubbliche, per citare solo alcuni dei risultati conseguiti. Rappresentavano un invito a prefigurare nuovi modi di governo del territorio e, indirettamente, postulavano il cambiamento delle concezioni dell’urbanistica e della pianificazione. E questo, pur consapevoli che la trattazione della materia, di competenza regionale, faceva insorgere innumerevoli difficoltà, nei rapporti fra amministrazione centrale e regioni. Inoltre, e non da ultimo, in un contesto in cui il sistema politico-parlamentare si è tenuto lontano dalla materia del governo del territorio (l’urbanistica da sempre è materia socialmente e politicamente conflittuale), evidenziando la sua incapacità di approvare una nuova legge di principi condivisi a livello nazionale. I programmi ministeriali e le iniziative comunitarie postulavano l’esigenza di cambiare anche il modo di intendere l’urbanistica e il piano regolatore generale definito dalla legge n.1150/42, e “…di provvedere alla inattualità della nostra strumentazione urbanistica che richiede, (ancora oggi), un ripensamento profondo delle procedure di programmazione e progettazione delle trasformazioni” (Il progetto della densità. U. Cao, 2017). Si riteneva che il contenuto dell’auspicabile riforma urbanistica dovesse abbandonare gli elementi propri della regolazione pervasiva dell’assetto funzionale del territorio o quelli concernenti la configurazione della coppia piano strutturale/piano operativo (all’attenzione, in quello stesso periodo, di una parte della cultura urbanistica italiana) ma anche gli infruttuosi e inconcludenti tentativi parlamentari di una legge-quadro sul governo del territorio. Si preferiva, piuttosto, l’ipotesi che il piano si trasformasse in una sorta di agenda con l’obiettivo di portare a coerenza un certo numero di progetti d’area prioritari, selezionati e definiti consensualmente e finalizzati alla trasformazione della città.
Il progetto urbanistico si configurava come capacità di tenere insieme, in uno scenario tendenziale, visioni al futuro, programmazione degli investimenti in settori di forte interesse prospettico (paesaggistico-ambientale, della mobilità, del sostegno allo sviluppo, di coesione sociale, di mitigazione degli squilibri territoriali ), regolazione dei territori interessati. Dava, inoltre, l’insieme di quei programmi, indicazioni di progressiva messa a punto d’idonei profili di governance e degli strumenti tecnici più idonei al conseguimento degli obiettivi proposti.
A fronte di una consapevole conoscenza parziale del progetto d’intervento, doveva essere garantita a ciascun attore una certa libertà di movimento nell’individuazione e nell’approfondimento della sua posizione, nel cambiare gli stessi modi e regole della sua presenza, nell’elaborazione dei dossier di partecipazione, nel poter pianificare le sue scelte, nell’intraprendere le azioni conseguenti perché privo di una conoscenza dettagliata ed esauriente della partita da giocare, essendo questa, sin dall’inizio, la condizione di base del processo auspicato.
Anche le amministrazioni pubbliche, centrale e locale avrebbero dovuto esporsi, confrontarsi, adattare i loro poteri d’indirizzo e pianificazione, individuando soluzioni coerenti con il percorso strategico che si andava faticosamente costruendo. Essere, sentirsi, comportarsi come uno dei soggetti, fra i molti, con cui sottoscrivere il contratto, questo sarebbe stato un comportamento appropriato.
Il capovolgimento del paradigma corrente proposto da quelle pratiche sembrava a portata di mano.
Già da qualche anno, era stato istituito il Ministero per i problemi delle aree urbane (per qualche giorno, durante l’elaborazione del programma del Governo Goria e fino a qualche ora prima del giuramento dei Ministri, si pensava di chiamarlo Ministero per le aree metropolitane), accogliendo la domanda crescente di qualità urbana, categoria d’intervento che negli anni aveva sostituito quella del fabbisogno abitativo. L’integrazione orizzontale e verticale di settori e livelli della pubblica amministrazione sembrava inaugurare un periodo di nuovo sperimentalismo istituzionale. Soprattutto, era pressante, nella discussione politica, la necessità del cambiamento del sistema politico e amministrativo locale.
La grande stagione politico-istituzionale caratterizzata dall’elezione dei primi Sindaci eletti direttamente dai cittadini permise di introdurre elementi profondamente innovativi nell’organizzazione amministrativa delle città. Furono di quegli anni, come già detto, i primi tentativi di una politica urbana, concretamente avviata di concerto fra Amministrazione centrale dello Stato e Comuni che, attraverso programmi di “rigenerazione/ riabilitazione urbana”, pose l’obiettivo della qualità urbana al centro della propria azione, avviando consistenti processi di riqualificazione di parti di città caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale(oltre a interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia di singoli edifici avviati grazie al così detto “sconto fiscale”).
La contraddizione che andava emergendo nelle esperienze di riqualificazione urbana fra interventi per pezzi di città e le tendenze in atto verso l’unione territoriale e l’addensamento urbano (la glocal city nel linguaggio della commissione europea); il dialogo sempre più serrato e incisivo con l’Europa, soprattutto con riferimento ai profili di coesione sociale e territoriale; i problemi della mobilità e della logistica sia negli spostamenti interni alle città, in termini di maggiore vivibilità, sia nei riguardi delle loro connessioni con bacini economici e sociali distanti o localizzati in altri Paesi, dal punto di vista della loro attrattività e capacità di competizione; tutte queste condizioni portarono in evidenza, in quegli stessi anni, la questione del forte intreccio tra luoghi e flussi, fra ambiti territoriali definiti e localizzati e la fluidità delle comunicazioni materiali e immateriali, di persone, cose, merci, informazioni.
Come si è già detto, i flussi scardinano gli assetti amministrativi dati, ne dimostrano tutta l’arretratezza, “parlano una lingua che amministrazioni spezzettate e concentrate nelle dinamiche interne non capiscono”.
Le elaborazioni allora sviluppate portarono, fra l’altro, alla definizione delle “piattaforme strategiche territoriali” (da quelle di rilevanza transnazionale a quelle regionali) e degli “agganci” all’Europa, all’individuazione dei territori-snodo e al potenziamento di vaste aree territoriali (già attrezzate da corridoi infrastrutturali viari e ferroviari e da connessioni con il sistema delle città), in grado di configurare macro-regioni europee (ad esempio, la magro-area del Nord del Paese, da Trieste a Torino, con la costruzione dell’alta capacità ferroviaria, il rafforzamento del sistema viario stradale e autostradale la realizzazione delle connessioni nord-sud con i porti di Genova e di Trieste e il potenziamento del sistema aeroportuale. Analoghe proposte, naturalmente, furono elaborate per il Centro, il Sud, e le Isole).
La politica, si sostiene, avrebbe il compito di mettersi in mezzo fra flussi e luoghi, di combinare, progressivamente, la parte più avanzata e dinamica con quella più statica, la città con la campagna (nelle riflessioni di una volta). In realtà, non sembra che sia questo l’obiettivo, anzi, il lavoro più proficuo sembra muoversi perché questa ricomposizione non avvenga.
Quello stimolo alla ricerca e all’innovazione, infatti, negli anni successivisi si è lentamente frammentato con l’abbandono progressivo delle esperienze più promettenti e l’arretramento, fino alla scomparsa, dell’attenzione, del consenso e della partecipazione che sembravano averle caratterizzate.
Non sempre e dovunque. Ad alcune condizioni e in alcune realtà territoriali quelle esperienze sono proseguite. L’alta velocità che da Milano porta prima a Roma e poi più giù fino a Salerno ha accorciato l’Italia, è come se la distanza si fosse improvvisamente ridotta e il tempo guadagnato. Nella rappresentazione grafica, è come se l’Italia si fosse schiacciata verso il Nord, restringendosi; allungando, purtroppo, la forma dello stivale verso il Sud fino alla Sicilia, dove i tempi di percorrenza se non sono aumentati sono rimasti inguaribilmente gli stessi di trent’anni fa. Analoghe condizioni di disagio sono pagate dai grandi nodi urbani, dalle comunicazioni a corto raggio per gli spostamenti dei pendolari e dai due grandi corridoi tirrenico e adriatico. Una scelta politica che ha puntato tutto (ricomprendendo anche la tratta Torino-Milano) sulla dorsale centrale con l’effetto di migliorare enormemente le comunicazioni e gli scambi professionali, economici, turistici (secondo Trenitalia, circa il 30% dei turisti viaggiatori si fermano almeno in due città fra quelle collegate) fra le sei principali aree metropolitane del Paese (si stima che il 66% degli abitanti risiederà nelle 14 aree metropolitane entro il 2050).
L’aspetto più interessante dell’AV è, forse, la relazione che si è andata stabilendo fra Roma e Milano. Vista la quantità e la qualità dei flussi e degli scambi in entrambi i sensi esistenti fra le due città, appare con tutta evidenza che si è venuta a creare una “diade,…una coppia di città che via via si integrano come avviene in altre parti del mondo con ben altre distanze con le quali fare i conti”.(A. Balducci-P. Perulli)
Due grandi aree territoriali specializzate, due grandi centri di servizi complementari ?
Milano, città europea, è sede privilegiata dell’economia, della produzione, della finanza, del dialogo con il mondo, del mercato globale e, ormai, anche della moda.
Roma, principalmente se non esclusivamente (almeno per ora), rimane la sede della politica e di servizi più tradizionali. Una nuova forma di scambio ineguale.
5. Per tutti gli anni novanta, come abbiamo visto, pur attraverso risposte differenti fra le diverse aree del Paese (peraltro, lo stesso avveniva negli altri paesi europei), le linee di lavoro si muovevano sull’ipotesi delle città come motori di sviluppo, nelle quali, era l’imperativo, tentare di coniugare eccellenza economica e misure di coesione sociale (e, in qualche modo, almeno come linea di tendenza, ci si era riusciti).
Dalla fine di quel decennio e nei primi anni del duemila, l’attenzione si era progressivamente allargata al sistema delle città, al policentrismo, al riequilibrio territoriale a media e a grande scala.
Era un’indicazione molto chiara, punto centrale dei processi di sussidiarietà nelle politiche di coesione e sviluppo della Comunità Europea. Basta andare con la memoria allo Schema di Sviluppo Spaziale Europeo (lo SDEC) o agli schemi di azione formulati a Lisbona: richiamo costante agli Stati membri a finalizzare gli investimenti all’integrazione fra rete TEN (quella dei collegamenti transnazionali bilaterali e multilaterali) e infrastrutture di rango regionale e locale.
Negli ultimi dieci anni, la grande crisi economica ha spazzato quanto si era fino allora costruito; esperienze in via di rafforzamento che stavano producendo un positivo effetto leva (anche con riferimento a finanziamenti pubblici e privati) si sono interrotte; il senso e il contenuto di quelle riflessioni e attenzioni si è progressivamente perso, le questioni sono rimaste appannaggio di pochi cultori, le attualità sono diventate ricordi.
Anche la riflessione sull’urbanistica, dopo un’intensa attività legislativa e regolamentare delle Regioni che, comunque, non si era distaccata molto dalla cultura della “regolazione senza visione progettuale”, non sembra essersi sottratta al generale senso di oblio e affaticamento. Da una decina d’anni, sfiducia e rassegnazione accomunano l’azione del Governo e del Parlamento con quella delle istituzioni regionali.
Le forti ristrettezze economiche e finanziarie dei bilanci pubblici, le profonde trasformazioni industriali (la scomparsa dell’industria pesante e delle grandi concentrazioni settoriali – chimica e siderurgia, innanzitutto – a favore delle filiere), l’abbandono del capitalismo pesante a favore del capitalismo leggero del Nordest, gli sconquassi sociali, il consolidarsi in forma endemica di quote di disoccupazione, particolarmente femminile, profondamente diverse fra Nord e Sud, la dequalificazione professionale e culturale, l’aumento degli squilibri fra le grandi aree geografiche, da sempre la più grande questione nazionale, la denatalità, tanto più evidente e preoccupante al Sud, che riduce l’asse portante della vita riproduttiva e attiva del Paese accentuando declino demografico e crescita economica, hanno evidenziato le fratture storicamente presenti nel generale assetto economico e sociale del Paese.
Non dovunque. Milano a differenza di Roma, per esempio. Milano, nello scenario che si era determinato, ha continuato a preferire l’approccio per progetti, a coinvolgere un ampio partenariato istituzionale ed economico-sociale orizzontale e verticale, a rafforzare la cultura della città e la qualità dello spazio fisico (qualità fortemente criticata da alcuni). E questo, pur non essendo Milano, ”…in contrapposizione alla capitale, un modello positivo di buon governo, con capacità di crescita e persino rinascimento urbano e con la situazione urbanistica non più degna” di quella di Roma”. (Urbanistica del progetto…P. C. Palermo, cit.).
Sicuramente, “il piano (urbanistico) del sindaco Moratti (non può) essere considerato un degno paradigma disciplinare,… un ragionamento urbanistico sulle trasformazioni in atto (avrebbe potuto) offrire alla città stessa argomenti di qualche interesse…(ma) è un dato positivo il fatto che, dopo una stagione interminabile di immobilismo e incapacità d’azione, finalmente la trasformazione… sia stata almeno in parte realizzata. Gli esiti, però, non dovrebbero giustificare celebrazioni irriflessive e un po’ provinciali. Una grande opportunità sembra al momento seriamente compromessa. Eppure le torri svettanti (non importa in quale contesto e con quali effetti reali?) sembrano rappresentare per larga parte dei media e forse dell’opinione pubblica una prova ulteriore del rinascimento di Milano. La mia conclusione è diversa. Se l’urbanistica avesse ancora un qualche valore e una certa capacità di influenza, sarebbe in grado di accompagnare le trasformazioni urbane verso esiti più degni. Come accade in altri paesi“. (P.C. Palermo, cit.).
La nuova Giunta ha investito 11 milioni sul risanamento delle periferie che a Milano sono in centro, con continui e improvvisi cambiamenti del paesaggio urbano e pezzi di territorio abbandonati alla criminalità. Anche in una situazione urbanistica così negativa, la città ha saputo offrirsi come luogo dalle eguali possibilità di successo, città della creatività (capitale della moda, del design e dell’arredo e del made in Italy) e della ricerca, ha continuato a potenziare le reti professionali e tecniche e l’offerta di servizi pubblici. Anche l’accettazione da parte dell’opinione pubblica, pur senza darle eccessivo peso nell’ambito di una valutazione critica, è un indicatore della crescente domanda di contemporaneità, un tentativo di comprendere ciò che sta avvenendo nella trasformazione dei tessuti urbani, con l’inserimento di produzioni firmate da grandi architetti.
“Milano, pur fra tante amnesie e interruzioni di continuità, è riuscita a riconquistare il suo posto tra le grandi città terziarizzate del mondo.….E’ riuscita a far sua l’idea che il gusto e l’eleganza non sono rendite di posizione ma continue sfide nel rapporto con il mercato….Altro fattore di successo… riguarda gli stili di vita e il peso che ha assunto nel determinare l’attrattività delle città. Per molto tempo, abbiamo considerato questo fattore d’innovazione come bizzarro o fatuo, non avremmo mai immaginato che con l’evoluzione delle economie moderne si sarebbe trasformato in capacità di attrazione, in elemento di comunicazione globale e di conseguenza in crescita economica.” (Il Corriere della sera, Dario Di Vico).
La classe dirigente degli ultimi anni ha saputo, con saggezza, cogliere lo spirito del tempo, non si è arroccata a difesa di posizioni di rendita. ” Le trasformazioni della struttura economica e della cultura della città hanno determinato profondi mutamenti della composizione stessa delle élite milanesi, …che hanno preso due direzioni intrecciate tra loro, la scena internazionale e la cura meticolosa delle competenze professionali…C’è stato un lento processo di sostituzione e via via la reputazione internazionale ha preso il sopravvento sulle logiche “castali” di tipo domestico…si è passati a una “nuova borghesia delle competenze”… che guarda e vive nel mondo, ma pur globalizzata non è disinteressata al “luogo” e infatti rimane radicata in città. (Il Corriere della sera, cit.).
Ritorna con forza in evidenza quanto sostenuto in precedenza: la possibilità per un territorio di rigenerarsi, di offrirsi in termini di attrattività, di affermarsi tra le grandi economie urbane sta nella capacità dell’amministrazione pubblica insieme alla società civile di intrecciare la dimensione materiale (l’insieme degli interventi, delle infrastrutture e delle scelte che modificano l’assetto fisico dei luoghi) con la dimensione immateriale (che è fatta di identità, cultura, organizzazione, capitale sociale, risorse), oltre i confini locali, sapendo governare le diverse scale in cui si articola la visione strategica che è possibile costruire intorno a un progetto per quel territorio.
Aver lavorato per anni, anche sotto traccia, al rafforzamento di queste condizioni, ha permesso a Milano di potersi candidare alla fine del 2006 all’organizzazione dell’Expo 2015 (l’altra candidata era la città turca di Smirne), e di vedersene assegnata l’organizzazione a marzo del 2008 dall’Ufficio Internazionale delle Esposizioni-BIE (86 voti contro 65). “L’Expo è stato, con la forza del suo impatto e della comunicazione, il luogo di coagulo di questa emersione ed è servito a generare ulteriore valore”. La città è così diventata, grazie alla posatura e alla cura che ha dedicato alle ”reti” nazionali e internazionali, …“una tappa degli itinerari globali, che le ha permesso di sottrarsi a una vicenda nazionale segnata da profonde difficoltà e da un clima angosciato.” (Il Corriere della sera, cit.)
E’ di questi ultimi mesi la vicenda legata allo spostamento dell’Agenzia europea del farmaco (EMA) da Londra. La Commissione europea ha reso note le valutazioni sulle città candidate a ospitare l’Agenzia (sono 19) e Milano ha i requisiti tecnici, organizzativi e logistici attribuiti alle città meglio piazzate nella corsa. Milano è stata valutata positivamente per i collegamenti, per un’ottima rete dei trasporti e un buon mercato immobiliare, per la capacità di consentire la continuità operativa, per l’offerta di una sede adeguata (il Pirellone), per il buon livello delle scuole, per l’efficienza dell’assistenza sanitaria e la dinamicità del mercato del lavoro. L’Agenzia attira quotidianamente centinaia di addetti del settore farmaceutico da tutti i Paesi europei e si stima che produca annualmente trentamila presenze in albergo per la città ospitante.
E così, grazie alla presenza di amministrazioni mediamente capaci, di una nuova borghesia delle competenze con capacità organizzative, al procedere dei processi di riqualificazione dello spazio urbano e di trasformazione della città e del territorio, di aver inseguito l’Expo come occasione di rinascita e, perché no!, con la complicità della grande crisi di Roma e della sciatteria della classe dirigente e del personale politico della Capitale, Milano è diventato “un posto nel quale, anche partendo da città europee (e non), ci si trasferisce”.
Roma, invece, è una città del No! Immobilismo e incapacità d’azione, come per la Milano di venti anni fa, caratterizzano la città e sono il motivo per cui Roma è uscita - o non è mai entrata a far parte - di nessun circuito internazionale, con l’unica eccezione di quello recente, che funziona a fasi alternate, del “Festival del cinema”. L’organizzazione delle Olimpiadi del 2024 sarebbe stata l’occasione da cogliere al volo, piuttosto che radicarsi nella tradizionale condizione economica caratterizzata dal terziario impiegatizio e dal mattone ma tant’è!
Si è preferito dar voce (e che voce!) al progetto del nuovo stadio della società di calcio Roma spa.
La proposta iniziale prevedeva oltre 1milione di mc di nuova edificazione, l’accordo è stato raggiunto intorno a 600 mila mc d’incremento delle previsioni di piano e con lo stralcio, ben gradito dall’operatore privato, di opere pubbliche di rilevanza urbana rinviate a una futura realizzazione, non si sa da parte di chi e di cui non si cura neanche il Comune.
“Il progetto urbano (è stato rimosso e sostituito) con l’accordo politico per una sommatoria di soluzioni puntuali, che rinviano al primato dei singoli oggetti e a considerazioni di opportunità del tutto indifferenti al contesto d’insieme, attribuendo invece un’ importanza taumaturgica alle quantità da realizzare; sicché un progetto diventa accettabile se soltanto si dimezzano le volumetrie a disposizione, indipendentemente dagli assetti insediativi previsti e dalle qualità conferite al contesto….Nessuna attenzione alla qualità, al funzionamento complessivo e all’idea di città sottesa da questa nuova area di sviluppo da realizzare in deroga al piano; piuttosto un confronto accanito sugli indici di edificabilità,…non diversamente del resto da quanto si è fatto nell’indecente processo di costruzione delle periferie circostanti.” (Verso la riforma del progetto urbano, 2017, A. Clementi). “La sostanza del confronto e il primato dell’attenzione tendono a ridursi alla misura degli indici di edificabilità…caso emblematico di frattura fra regolazione (edificatoria) e progetto (di territorio). Non esce da questa logica quella cultura urbanistica che si limita a criticare la vicenda perché le cubature del compromesso sarebbero ancora troppo elevate…Il nodo più critico è la mancanza di progettualità: urbana, ambientale e territoriale .” (Urbanistica del progetto…P. C. Palermo, cit.). Roma, dove quasi tutto o tutto è pubblica amministrazione, priva com’è (e come è stata negli ultimi 10 anni) di una dirigenza politica e amministrativa colta e consapevole del proprio ufficio, di una classe dirigente privata immune da posizioni estrattive e in grado di fare a meno dei benefici offerti dalla rendita edilizia, con il centro storico e i suoi quartieri, anche i più belli, oppressi da pizzerie al taglio e cumuli di cianfrusaglie, con ceti sociali privi d’identità, non può essere governata soltanto con la proposta di programmi ordinari, fatti di "…innovazione, Infrastrutture, con grandi opere ma anche piccoli interventi che possano ricucire i tessuti urbani, Zero Burocrazia e Defiscalizzazione, una leva necessaria affinché Roma diventi centro di investimenti e polo attrattivo per le imprese estere" (Fabbrica Roma).
Roma capitale (che ospita, fra l’altro, lo stato estero della Città del Vaticano) è “sede degli organi costituzionali, delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica Italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali” (art. 24 della legge delega n.42/2009). Il suo statuto richiederebbe un ordinamento speciale e la creazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Dipartimento (o di un ufficio speciale o di missione) diretto da un Ministro senza portafoglio, che sieda alle sedute del Consiglio dei Ministri e che possa svolgere funzioni di interfaccia con l’Amministrazione comunale e d’impulso e coordinamento delle attività e delle iniziative delle amministrazioni centrali dello Stato.
Gli ultimi interventi infrastrutturali di un qualche rilievo risalgono ormai alla fine degli anni ’80. Le Olimpiadi (o qualunque altro programma straordinario, anche con carattere emergenziale, come sembrerebbe richiedere lo stato comatoso (?) di Roma) sarebbero state …“una sorta di piccolo Big Bang della Roma smarrita che si sarebbe ritrovata nell’universo dello sport…Roma poteva diventare più Roma…. (le Olimpiadi) sarebbero state comunque ricchezza, risorse, opportunità, posti di lavoro, il riscatto di una città che è la grande bellezza svillaneggiata dal mondo perché Roma, scrisse il New York Times, solleva nuove domande circa la capacità dell’Italia di riformarsi” (La Repubblica, F. Merlo). Se non vi è dubbio che un certo grado di discrezionalità sia necessario nei processi di trasformazione e governo del territorio, l’indispensabile esercizio della discrezionalità deve essere bilanciato da un’altrettanta chiara assunzione di responsabilità politica e amministrativa, nell’immediatezza delle scelte operate e in seguito, quando sarà necessaria una loro più attenta valutazione. Sarebbe stato semplice per un’amministrazione matura, fornita dei necessari anticorpi, utilizzare tutti i dispositivi, gli strumenti e le procedure esistenti per il controllo delle gare per l’affidamento dei lavori e per le attività nei cantieri, o di proporre altri sistemi innovativi da elaborare per l’occasione più attenti alla varietà e sensibilità dell’ambiente, coniugando capacità d’azione positiva e immunità dai rischi del primato di interessi di parte.
“La difficoltà maggiore in questo nuovo modo di intendere il progetto urbano sta nella necessità di riformare l’amministrazione pubblica, in particolare a livello comunale…Purtroppo l’esperienza insegna che in assenza di oscure convenienze, l’atteggiamento dei funzionari è di evitare il minimo rischio, scoraggiando di fatto la promozione di quei progetti che devono guadagnare sul campo la propria legittimità, e dimostrare adeguatamente le convenienze pubbliche alla trasformazione. E la situazione attuale sta perfino peggiorando, per la generale involuzione del dibattito sulla città e per la manifesta incapacità del mondo politico a coglierne l’importanza cruciale nel cambiamento dell’economia e della cultura contemporanea. (Verso la riforma…A. Clementi, cit.) Dicevano di non volere edifici sviluppati in altezza, in realtà si sono accontentati di costruire il poco che basta allo stadio della Roma.
6. Gli Stati, i territori, le città sono sempre più in competizione per attrarre investimenti. Finora la competizione è stata avviata da soggetti pubblici in conformità a bandi di gara pubblici.
Una stazione appaltante pubblica (nel caso delle Agenzie europee, le decisioni fanno capo alla Commissione o allo stesso Consiglio dei Capi di Stato e di Governo), in conformità a una procedura a evidenza pubblica, individua un soggetto o un’impresa privata per costruire un’opera pubblica, per realizzare importanti interventi infrastrutturali o per fornire un servizio di pubblica utilità. Lo stesso vale per il dialogo competitivo e per le procedure negoziate per l’avvio di un partenariato pubblico-privato. Ora, i ruoli si sono rovesciati.
Amazon ha recentemente pubblicato un avviso rivolto a Stati, contee e città metropolitane degli Stati Uniti perché avanzino proposte di candidatura per la localizzazione di un nuovo quartier generale della Società simile a quello in funzione a Seattle. L’investimento è di 5 miliardi di dollari per 50 mila posti di lavoro, e le amministrazioni pubbliche (concorrenti!) sono invitate a offrire le condizioni migliori per ospitarlo.
Il “bando” (è questo il nome che gli spetta) descrive l’intervento, i tempi e le caratteristiche dell’investimento e le condizioni di partecipazione. Riporta la descrizione dell’azienda e della sede di Seattle il cui investimento ha generato in sei anni (dal 2010), 38 miliardi di dollari di indotto a favore del territorio. Fra i criteri di scelta, sono indicati un’area metropolitana di oltre un milione di abitanti, ambiente stabile e “business-friendly”, tessuto urbano o suburbano idoneo ad attrare dipendenti altamente qualificati (con salario medio annuo di centomila dollari), sito già predisposto per un insediamento industriale e ben collegato con le reti di trasporto, connettività in fibra elevata, qualità della vita nella comunità, offerta culturale e presenza di istituzioni universitarie specializzate soprattutto nelle discipline tecniche e scientifiche di interesse di Amazon.
Il bando continua con l’indicazione di altri elementi di localizzazione (come incentivi fiscali, finanziari, tariffari e non, contratti di lavoro). La Società, dopo la presentazione delle offerte (in 5 copie cartacee), si riserva di negoziare con uno o più proponenti (una sorta di dialogo competitivo) per definire l’aggiudicazione e la firma del contratto. Il contraente è un’autorità pubblica che, come “appaltatore”, si deve far carico della corretta applicazione di tutte le clausole contrattuali nei confronti di un soggetto privato che, per l’occasione, riveste il ruolo di “stazione appaltante”. Un completo “scambio dei ruoli” fra pubblico e privato. Due questioni principali in questo caso sembrano rilevare con riferimento alla situazione italiana. La prima, di più immediata evidenza, attiene alla complessità e farraginosità del sistema legislativo e amministrativo (che si presume sia ritenuta pressoché incomprensibile da un soggetto come Amazon). Variegata molteplicità di soggetti pubblici e privati competenti a esprimersi su un intervento così complesso, autonomia finanziaria, fiscale, tariffaria, delle amministrazioni pubbliche interessate (a livello nazionale regionale e comunale) e conseguente impossibilità di offrire condizioni comparabilmente più o meno favorevoli, varianti urbanistiche che per l’approvazione debbono passare il vaglio di una innumerevole serie di autorità, anche preposte a tutele di rango costituzionale, di livello nazionale regionale intermedie locali e sub-locali, conferenze di servizio con durate incompatibili con le logiche industriali, contrattazione sindacale dagli esiti incerti, continua rimessa in discussione delle decisioni eventualmente assunte.
La seconda questione, che abbiamo trattato nelle pagine precedenti, riguarda l’attrattività e la competitività delle città e dei territori italiani. Molte iniziative hanno rinunciato a localizzarsi o preso in considerazione la possibilità di incrementare i loro investimenti in Italia. Altre si sono trasferite in Paesi diversi o hanno abbandonato città italiane preferendone differenti localizzazioni, per fortuna, sempre in Italia, lasciandosi comunque alle spalle disoccupazione e crisi economica.
Un grande evento o un’offerta come quella di Amazon (se mai se ne presentasse l’occasione), in questa competizione internazionale fra città e territori, preferisce le aree che ne possono ottimizzare la portata economica e di rilancio sociale e, nello stesso tempo, una volta atterrati nel luogo prescelto tenuto conto di parametri di attrattività e competitività, lo trasformano in un luogo globale, dove in modo semplice, quasi per contiguità, possono riprodursi condizioni favorevoli per innescare positivi processi che aumentano la ricchezza complessiva delle comunità interessate, con ricadute positive, prodotte dallo stesso intervento o spostate avanti nel tempo, di recupero e riscatto di zone o quartieri in stato di degrado e abbandono.