
Per un’architettura non edificante, Pippo Ciorra * |
1 - Genesi
Coltivo l'idea di questa mostra da almeno dieci anni, o forse un po' di più. Forse non è del tutto inutile ricostruirne la genealogia. Nei primi anni di lavoro nella Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno1 ci siamo resi conto, grazie allo sguardo attento e alla capacità di rappresentazione dei colleghi e dei miei studenti, di quanto fossero ormai spuntate le armi dell' "Architettura" tradizionalmente e accademicamente intesa nel tentativo di dare ordine e senso allo spazio contemporaneo e alla vita di chi lo abita. Il quale spazio a noi appariva nella forma florida, disordinata e allegra dello sprawl costiero medioadriatico fine anni '90, in pratica un catalogo di problemi, materiali e suggerimenti verso nuovi approcci al progetto: infrastrutture, casette, capannoni, paesaggio, memoria, seconde e terze case, spiagge, turismo, microimpresa, porti commerciali e turistici e chi più ne ha più ne metta. Da parte mia, data la poca dimestichezza con la landscape architecture e l'incapacità di soddisfare la mia libido architettonica con il semplice uso compulsivo di orti orizzontali e verticali, ho pensato che dovevamo metterci alla ricerca di un approccio diverso e dolcemente eversivo alla progettazione. Il punto di partenza era che sarebbe stato impossibile pensare di modificare realmente il paesaggio urbano con la pura aggiunta di poche architetture belle e buone nel mare dell'edilizia brutta e cattiva. La soluzione è stata allora quella di concentrarsi su uno sforzo ostinato e irriguardoso di recupero e trasformazione degli edifici e degli spazi esistenti, più o meno dismessi, più o meno banali, più o meno autoriali che fossero. Il processo era chiaro, i risultati anche (una mole di progetti che continua tuttora a crescere), quello che mancava era uno slogan o un'etichetta sotto la quale raccogliere gli esiti di questo lavoro e propagandarli. Me ne resi conto quando li presentai in un giro di conferenze in alcune università nordamericane nel 2000, in una delle prima uscite internazionali della città adriatica. Fino ad allora avevo raccontato il nostro come un esempio straordinariamente chiaro di paesaggio contemporaneo, stratificazione perfetta di natura storia e caos finenovecento, oggetto eletto di mappature accattivanti e analisi accuratissime. In quel caso invece, forte dei primi risultati di lauree, seminari, scambi con altre scuole italiane e non2, mi trovai a presentare i progetti miei e dei miei studenti come una risposta buona non solo come rimedio al disarmo dell'architettura nel [nostro] paesaggio urbano ma anche come possibile risposta globale alla crisi del linguaggio architettonico, stretto nella dialettica improduttiva tra postmoderno e ipermoderno. La mia proposta sembrava in genere ottenere consenso presso le piccole platee accademiche alle quali parlavo, ma ricordo distintamente uno studente di Cincinnati alzare la mano alla fine del talk e dire "questo approccio ci piace molto, ma come si chiama? Per affermarsi ha bisogno di un nome". Non sapevo rispondere. 0 meglio, sapevo tutte le definizioni che non andavano bene: restauro, riuso, modificazione, riqualificazione, ampliamento, demolizione-ricostruzione ecc. Per identificare una tendenza bisognava quindi trovare una definizione efficace, che ancora non saltava fuori. Qualche anno dopo, siamo intorno alla metà dello scorso decennio, un primo aiuto sostanzioso mi è venuto da Aldo Aymonino e Valerio Paolo Mosco, che mi hanno chiesto un testo per il loro Spazi pubblici contemporanei. Architettura a volume zero 3, e mi hanno dato l'occasione sia di riflettere sugli incroci e le sovrapposizioni della mia ricerca con quelle di altri, che di cominciare a investigare le relazioni tra un approccio contestual-situazionista come il mio e i precedenti molto più nobili della ricerca architettonica e artistica di carattere concettuale 4. Il passo successivo, più o meno negli stessi anni in cui i due autori citati lavoravano per sdoganare I'"architettura a zero cubatura", fu l'arrivo di una giovane dottoranda che venne da me chiedendomi di seguirla in una ricerca sull'architettura parassita 5. L'idea ovviamente mi piacque molto: mi sembrava un'ottima occasione per affrontare seriamente un tema che era stato sfiorato frequentemente da architetti e artisti per tutto il Novecento e allo stesso tempo apriva una fase di crescita essenziale per le nostre ricerche sul "costruire sull'esistente". Ho quindi accolto volentieri la proposta di Sara Marini, che non a caso figura tra i curatori di questa mostra e di questo catalogo, e così ho potuto giovarmi del suo prezioso lavoro come di un riferimento e un'interlocuzione essenziale per la definizione di un approccio teorico originale alla questione in oggetto. Quando poi ho intrapreso la mia collaborazione con il nuovo MAXXI ho capito che era finalmente venuto il momento di trasformare dieci e più anni di elaborazioni sparse nella forma e nella sostanza di una mostra e di una tentative theory dell'architettura. A quel punto lo spunto per dare un nome a un approccio e alla mostra stessa è venuto dalla società e dal nostro tempo, ormai giustamente ossessionati dai temi dell'ecologia, della sostenibilità, dello smaltimento dei rifiuti e dell'urgenza di adottare materiali e risorse riciclabili. Improvvisamente è stato chiaro che il nocciolo della questione attorno alla quale giravamo da tre lustri era lì a portata di mano: l'architettura è di per se un materiale riciclabile, che tra l'altro sappiamo riciclare da sempre 6. La novità postmoderna da sottolineare è che il riciclaggio – o riciclo che dir si voglia – non è più solo un dispositivo economicamente, politicamente e antropologicamente corretto ma anche una delle forme più sofisticate e attuali della ricerca espressiva degli architetti contemporanei. Tanto da aver prodotto negli ultimi anni una mole di edifici, progetti, ricerche da rendere davvero difficile il nostro lavoro di selezione, poiché perfino il museo disegnato da Zaha Hadid nel quale lavoriamo – per quanto grande e fluido – è uno spazio finito.
2 - Capisaldi
L'idea di una potenzialità ideologica del riciclo architettonico è ovviamente tutt'altro che inedita. Dagli anni settanta del secolo scorso in poi ci sono capisaldi senza i quali il discorso sul riciclo rimarrebbe confinato nell'ambito della bella politica urbanistica. A parte alcuni folgoranti ballon d'essai figurativi sparati qualche anno prima dagli Archigram o dagli architetti Radicali, l'idea che un progetto architettonico o urbano potesse fondare la sua identità figurativa sul fatto di essere frutto di un'opera di riciclaggio diventa chiara con una serie di "progetti d'autore" databili tra la fine degli anni settanta e l'inizio dei novanta. A un estremo del campo di sperimentazione troviamo i capolavori dell'architettura del riciclo concettuale – il Parco della Villette e la scuola Le Fresnoy di Tschumi e il progetto per Cannaregio di Peter Eisenman 7 – certamente debitori nei confronti del dialogo con artisti (Acconci) e filosofi (Derrida), ma comunque cruciali per farci comprendere che il significato e il valore d'uso dell'architettura non possono più identificarsi solo con la sua natura tettonica e di colonizzazione del vuoto. All'opposto troviamo la versione apparentemente più artigianale e situazionista del riciclo messa in scena da Lacaton & Vassal nel progetto di trasformazione del Palais de Tokyo da sonnecchiante museo municipale a teatro della ricerca artistica d'avanguardia 8. L'insieme di questi lavori ha reso chiaro a tutti come l'architettura a cavallo tra la fine del secondo millennio e l'inizio del terzo abbia dovuto imparare a trattare il pieno e il vuoto, l'esistente e il nuovo, l'urbano e l'antiurbano con la stessa dimestichezza e con la stessa intensità progettuale, tenendo ben presente come non sia più possibile considerare queste coppie nei termini di una pura opposizione dialettica.
Anche il versante più ortodosso della cultura architettonica italiana, stimolata dalla presenza di enormi dotazioni di architettura da conservare/restaurare/ riusare/riciclare, si è spesso confrontata con il tema del riciclo, spostandolo però quasi sempre verso la scala della città e del territorio. Ricordiamo tutti l'editoriale del numero 498/499 di "Casabella" 9, con il quale Vittorio Gregotti, col forte sostegno di Bernardo Secchi, ci spiegava quasi trent'anni fa che il futuro della nostra architettura era nella modificazione dell'esistente. Gregotti però, fedele a un'idea modernista di centralità dell'urbanistica, non si spingeva allora fino a estendere il concetto di modificazione all'edificio e alla sua natura variamente riciclabile, che rimaneva delle mani non sempre sapienti degli esperti di restauro e di ristrutturazione. Col tempo però la crescente massa di edifici di ogni genere natura e valore che concludono il loro ciclo di vita sul territorio nazionale ha reso evidente l'inadeguatezza delle culture tradizionali del restauro e del riuso davanti alla miriade di case, scuole, edifici pubblici, fabbriche, capannoni che nella maggior parte dei casi non meritano un approccio conservativo e che pure per mille ragioni non conveniva e non conviene demolire. Urge quindi una cultura del riciclo – del Re-cycle – che sia tanto audace e infedele quanto il restauro mainstream è attento e (non sempre sinceramente) fedele all'originale e tanto veloce, uncanny e indeterminata quanto l'approccio consueto al "riuso" è pedante, puntiglioso e burocratico.
3 - Confronti
L'architettura è un'arte negoziale, che produce il suo linguaggio attraverso la mediazione tra tre tipi diversi di istanze, quelle della tecnica, quelle della sua propria storia e delle regole interne della disciplina, quelle della società e del tempo che abita. Quando l'ossessione produttiva, creativa o politica dell'architetto decide di identificare interamente o prevalentemente l'architettura con una delle tre istanze la espone al rischio dell'autoreferenzialità, ne mina l'utilità sociale, prosciuga pericolosamente le sue fonti di energia. Sono rischi che hanno nome e cognome, basta pensare alla prima e più ingenua fase dell'hi-tech, alla versione più ossessiva e ideologica dell'autonomia, agli equivoci che per decenni hanno accompagnato il concetto di partecipazione. Viceversa è ovvio che per alcuni progettisti l'obiettivo è proprio quello di camminare sul baratro senza caderci dentro, sull'orlo del sublime. Sembra un discorso astratto, o un calembour da critico, ma basta pensare, nell'ordine, al lavoro di Richard Rogers, Aldo Rossi e Peter Eisenman, o di Giancarlo De Carlo per capire come questi autori hanno fatto della "quasi morte" dell'architettura per troppa identificazione con una delle sue componenti il punto di forza del loro lavoro. Ciò che però ci interessa adesso di questo intreccio di relazioni delle quali si nutre l'architettura nell'introdurre questa mostra, è come una delle componenti essenziali dello scambio con la società e con il proprio tempo sia il dialogo con l'arte, i linguaggi visivi e le altre forme espressive. Per questo una delle mosse iniziali di questa ricerca sul riciclo è basata su uno sguardo che si muove liberamente all'interno e all'esterno del perimetro architettonico. Dall'universo specifico dell'architettura, dai monumenti di Roma antica, cento volte riciclati, al Palazzo di Diocleziano a Spalato, scopriamo come la storia dell'architettura e della città sia da questo punto di vista un testo ricchissimo, molto utile a comprendere il presente. Dall'arte, dalla letteratura, dai media, e da altre e meno auratiche attività produttive del nostro tempo, impariamo invece come il riciclo critico e consapevole di un'opera sia non solo una delle pietre miliari della modernità (dalla "Gioconda coi baffi" di Duchamp alle lattine Campbell di Warhol) ma uno dei più fertili dispositivi creativi che attraversano con disinvoltura il confine tra produzione e arte 10. Non è un caso infatti che accanto alle ponderose riflessioni sul paesaggio italiano e sulla storia delle rovine "riciclate" la scoperta che più mi ha fatto capire che era il momento adatto per provare a trasformare una ricerca disciplinare in un meccanismo di comunicazione complesso e generalista come una mostra è stato un singolare episodio di storia materiale in epoca sovietica. Succedeva infatti negli anni sessanta e settanta che fosse proibito ai russi importare dischi di musica "occidentale", dove per occidentale si intendevano il jazz e il pop-rock. Per aggirare la proibizione e rimediare alla grave carenza i russi avevano inventato un dispositivo semplice ed efficace che consisteva nel traslocare le macchine per stampare il vinile negli ospedali e di usare, al posto del vinile "vergine", le lastre radiografiche usate. Col risultato folgorante — esposto nella mostra — di avere Jimi Hendrix sovrascritto sulla lastra di un cranio fratturato o i Rolling Stones incisi sulle ossa artritiche di due mani eccetera. Ciò che fa di questo precedente un paradigma è il meccanismo (quasi) involontario che trasforma un riuso funzionale in un gesto creativo, un dispositivo funzionale nella genesi di un'opera a più strati.
Il ricorso alle lastre russe, generosamente segnalatemi dagli studiosi che ne scrivono in questo catalogo, ci ha permesso di definire con assoluta precisione l'ampiezza di questo lavoro, da un attento ai "fatti interni" della disciplina architettonica e urbanistica, dall'altro impaziente di metterla a confronto con il linguaggio artistico, con quello dei media, del video e della musica, con le tecniche creative nel senso più ampio del termine. La presenza in mostra, intorno ai reperti del nostro core business architettonico, di opere di artisti, videomakers, produzioni televisive e musicali e quant'altro non è però solo una testimonianza della capacità migratoria dei linguaggi espressivi e dell'ovvia natura eteronomica dell'architettura. La molteplicità delle opere recenti e dei linguaggi in mostra per noi è anche la prova di come il modo in cui il tema del riciclo attraversa oggi tutte le forme espressive lo renda un dispositivo efficace per avvicinarsi alla storia del pensiero e alla condizione contemporanea (post-postmoderna o neo-neorealista che sia). E quindi un'occasione di dialogo con il proprio tempo che l'architettura non può lasciarsi sfuggire.
4 - La condizione postpostmoderna
Re-cycle rappresenta per noi anche un modo per riflettere sulla condizione contemporanea dell'architettura e dell'arte. In tempi quanto mai intensi e contradditori, nei quali non siamo certo i soli a cercare di prendere le misure alla storia. Quasi in contemporanea all'apertura della nostra esposizione, il Victoria & Albert Museum di Londra propone infatti una una grande mostra sul postmodernismo (titolo Postmodernism. Style and Subversion 1970-1990 11), dove per postmodernismo si sceglie di intendere proprio quello che hanno in mente gli architetti: con-fusione di linguaggi, ampio ricorso alle forme del passato e libera citazione in libero testo. Non è un fulmine a ciel sereno, era nell'aria e pare che anche altri musei abbiano in preparazione iniziative simili. L'intenzione di rileggere quel periodo serpeggia già da un po' nel panorama del pensiero architettonico per motivi diversi: da un lato una specie di attitudine fisiologica del mercato culturale ad alimentarsi di corsi e ricorsi estetici, dall'altro la fatica disperante che fanno architetti e critici contemporanei a individuare tendenze nuove e interessanti che non siano l'ossessione tecno-ecologistica e un'ovvia ri-insistenza sui temi sociali. "It should be also clear — scrive Reinhold Martin nell'introduzione al suo Utopia's Ghost. Architecture and Postmodernism, Again 12 – that, in casting a backward glance, I do not attempt to reclaim postmodernism from its subsequent fate". Sarà così, e certamente il saggio in questione è un'opera seria e non ammiccante, ma resta il fatto che la citazione di chiusura della mostra al V&A, insieme a qualche progetto vintage che già comincia a girare, ha un suono molto più preoccupante: why can't we be ourselves like we were yesterday? 13. La stessa domanda, ma con intenti del tutto diversi, sembra farsela anche quel gruppo di intellettuali, un po' più pompiers, che a Roma e Bonn si preparano a celebrare il funerale definitivo del postmoderno, con annessa fine della centralità del linguaggio, in funzione di un imminente ritorno alla necessità di contenuto autentico e (addirittura) “vero” 14. Una specie di pensiero a chilometro zero, insomma. Chi avrà ragione? Non ci aiuta a stabilirlo Germano Celant, che anzi nel suo Arte Povera. Storia e Storie - che comunque precede un pirotecnico revival del movimento artistico in questione – imputa i tentativi di ritorno a tendenze passate a una specie di nostalgia dei bei tempi andati, quando gli artisti si riunivano in gruppi e identificavano tendenze 15. Nulla di più lontano dal presente, nel quale autori di ogni genere – architetti e artisti in primis – si presentano al mondo come fenomeni prettamente individuali, ostilissimi all'idea di condividere qualsivoglia obiettivo o di fare proseliti.
Che succede allora, come si fa allora a tracciare una mappa credibile del pensiero nel tempo presente? E soprattutto come può una mostra sul riciclo contribuire a tracciare questa mappa, a partire da due condizioni iniziali favorevoli: la prima da rintracciare nella naturale abbondanza di spirito del tempo in un argomento del genere; la seconda nella natura inclusiva del concetto Re-cycle, che non nega il passato, che ne riconosce la natura ciclica e ri-generante, che contiene però un dispositivo "re-" che consente sempre di mantenere la distanza necessaria a salvarsi dalle implicazioni reazionarie del conservare e del "guardare dietro" (teniamo ben presente la faccia anteriore dell'angelo di Benjamin). Sarebbe ovviamente velleitario affermare che il riciclo dei materiali architettonici e storiografici rappresenta una soluzione definitiva all'opposizione moderno-postmoderno, utopia-realismo, collettivo-individuale, ma di certo si tratta un'azione progettuale sempre spiazzante, una mossa del cavallo che può permetterci di rimettere in moto il nostro confronto con la realtà. Recycle è infatti una parola d'ordine che raccoglie infiniti possibili comportamenti individuali senza pretendere di assimilarli in una tendenza omogenea, tenendoli comunque ancorati a un principio di realtà fortissimo. Tutto ciò assume un'importanza ancora maggiore se oltre al contesto temporale pensiamo a quello fisico. Vale a dire al numero infinito di edifici, spazi urbani, paesaggi che in Occidente (e soprattutto in Italia) hanno compiuto il loro (ultimo) ciclo. Non solo luoghi inadeguati o dismessi, ma soprattutto progetti che hanno esaurito le loro risorse e la loro efficienza. La strategia del riciclo appare allora come un approccio che consente di tenere insieme memoria e innovazione radicale, realismo e tabula (quasi) rasa, una specie di piccola utopia socioespressiva che può guidarci nel ricostruire allo stesso tempo i territori e le teorie. L'idea del riciclo appare quindi in questo scenario come una specie di forma omeopatica della modernità, capace di assorbire il passato, il contesto, le identità preesistenti senza imitarle e senza lasciarsene sopraffare.
5 - Unbuilding Architecture
La parte più semplice di una ricerca sul riciclo in architettura è certamente l'individuazione di progetti e casi studio. La più complicata fissare con chiarezza il criterio per una selezione più ristretta, poiché il concetto di riciclaggio sfuma e si ramifica in mille direzioni diverse. Per cercare di non perderci abbiamo scelto di seguire tre percorsi precisi. Il primo percorso è quello nel quale il riciclo è inoppugnabilmente un atto di natura artistica, nell'accezione fissata una volta per tutte da Duchamp e sviluppata poi lungo il percorso della modernità attraverso il lavoro di mille altri artisti, da Gordon Matta-Clark a Song Dong. Questo ci ha permesso di trovare una misura spazio-temporale del nostro campo di lavoro e di provare ad allinearci alla storia lunga e importante di un pensiero creativo. Abbiamo così individuato una serie di lavori di artisti, architetti, media producers, "pezzi storici" che rappresentano le stelle polari della nostra rassegna attuale. Per quel che riguarda l'architettura abbiamo già parlato del Cannaregio di Eisenman, investigazione cristallina sul tema della sovrascrittura, e delle visioni di Superstudio e Archizoom, che insistono sul potere significante della differenza tra preesistenza e nuovo. Vale poi la pena di ricordare il riciclo concettuale del vagone ferroviario di Portaluppi, la scuola Le Fresnoy di Tschumi e molti lavori basati sul riuso dei container industriali. Il secondo percorso che abbiamo seguito è quello nel quale è sempre chiaro che il riciclo è un atto di natura materiale. La maggior parte dei progetti architettonici e artistici inclusi in questo catalogo partono da "rovine" esistenti e si relazionano al preesistente facendone un uso imprevedibile e non ortodosso. Questo vale per il bunker di sommergibili recuperato dai LIN a Saint-Nazaire o per la facciata riciclata dai Karo* Architekten ma anche per i reperti raccolti da Song Dong nella casa di sua madre, per l'isola di Hashima raccontata da Fischer & El Sani o dall'angoscioso waste scelto come soggetto fotografico da Pieter Hugo. Due lavori di autrici italiane, i Tunnel di Trento di Elisabetta Terragni e Casa Parisi Sortivo di Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, rappresentano campioni molto esatti di come i primi due percorsi possano intrecciarsi e sovrapporsi, assumendo uno specifico spessore disciplinare e quindi offrendosi come una possibile teoria dell'architettura.
Se il secondo misura la possibile profondità della nostra ricerca, il terzo percorso si snoda invece lungo l'estensione delle nostre discipline, fin nelle aree più vicine agli ambiti dell'ecologia e della responsabilità ambientale. È lungo questa direzione che troviamo tutti quei progetti urbani e di paesaggio che lavorano con tecniche assimilabili a quelle del riciclo architettonico. Essi rappresentano la risposta della cultura visiva e progettuale al problema della sostenibilità: ri-costruire invece di costruire: costruire sopra sotto intorno dentro addosso, con i materiali di scarto, invece che costruire, abitare la rovina invece di costruire, rinaturalizzare invece che riurbanizzare. Città che si ritirano e lasciano enormi territori abbandonati e semiabbandonati, attività industriali che muoiono o migrano altrove, comunità intere che si spostano lasciandosi dietro spazi non più utilizzati: tutto questo costituisce l'occasione per progetti di riciclaggio urbano che delineano ormai un paradigma del tutto nuovo per il progetto a grande scala e che completano alla perfezione la nostra rassegna. La High Line di New York, i primi interventi pianificati per la Shrinking Detroit, le proposte europee per Parigi, Barcellona, Monaco ci mostrano quindi come all'immensa produzione di scarto della nostra urban age (terzi e quarti paesaggi, territori di scarto, waste, rifiuto, interstizi vari) corrisponde ormai un armamentario di tecniche e strumenti di progettazione nuovi, fortemente incentrati sul concetto di riciclo.
In alcuni dei progetti esposti l'idea del riciclo può sembrare più immediata ed ecologica che negli altri. Negli edifici di MINIWIZ, costruiti utilizzando bottiglie di plastica e scarti industriali, o nella biblioteca del KARO` Architekten, che smontano e riutilizzano i moduli di facciata di un edificio demolito come finitura del proprio, così come nella High Line o nei parchi spagnoli ricavati dalle discariche, il trattamento del rifiuto, umano o urbano che sia, assume una forma letterale e politicamente ipercorretta. Ma un museo, e in particolare un museo che mette insieme architettura e arte contemporanea, non può non vedere i limiti di una visione puramente funzionale del riciclo. Per questo la mostra non rinuncia da un lato al continuo confronto con l'arte e con gli altri linguaggi espressivi e dall'altro a misurarsi con parametri filosofici, estetici e di gusto. A partire da questa rete di relazioni il riciclo può finalmente espandersi in direzioni opposte per diventare allo stesso tempo una tattica quotidiana socialmente condivisa e una nuova possibile teoria dell'architettura.
*curatore della mostra RE-CYCLE con Sara marini (architettura), Mosè Ricci (urbanistica e paesaggio), Paola Viganò (workshop e studi urbani) e Senior Curator del MAXXI Architettura
1 - La Facoltà di Architettura dell'Università di Camerino, localizzata ad Ascoli Piceno, ha aperto i battenti nel 1994. lo ho cominciato a lavorarci come ricercatore un anno più tardi, nel1995, nel 2010 la Facoltà si è felicemente trasformata in Scuola di Architettura e Design.
2 - Nel 1999 è nato il seminario itinerante di progettazione Villard, che coinvolgeva all'inizio sei facoltà di architettura italiane e che ha avuto in questa ricerca un ruolo di approvvigionamento essenziale. Il seminario, che nel 2011 è alla sua tredicesima edizione e interessa ormai una rete di circa quindici scuole italiane e non, ha rappresentato un luogo essenziale per lo scambio di conoscenze e per il confronto di strategie, consentendoci di mettere in relazione la nostra esperienza con i differenti contesti nazionali e internazionali.
3 - A. Aymonino, V Mosco, Spazi pubblici contemporanei. Architettura a volume zero, Skira, Milano 2006.
4 - P. Ciorra, Dai propilei alle nuvole, ibidem, pp. 315-322.
5 - La dissertazione conclusiva di Sara Marini è pubblicata quasi integralmente in S. Marini, Architettura Parassita. Strategie di riciclaggio per la città, Quodlibet, Macerata 2008.
6 - I testi di alcuni degli autori di questo catalogo - Ferlenga, Vidler, Lavin - ricostruiscono perfettamente gli elementi di continuità tra la consuetudine millenaria al riciclo architettonico e il ruolo particolare che questa pratica assume oggi.
7 - Quello di Eisenman per Cannaregio è un riciclo esemplare, prodotto dalla sovrascrittura di tre testi architettonici: il tracciato dello spazio aperto veneziano, il reticolo modulare del progetto lecorbusieriano per l'ospedale di Venezia e la punteggiatura architettonica dello stesso Eisenman, fatta di microedifici in sé privi di senso.
8 - Per la vicenda del Palais de Tokyo vedi soprattutto: P. Nicolin, Palais de Tokyo. Sito di creazione contemporanea, Postmedia Books, Milano 2006.
9 - V. Gregottl, Modificazione, in "Casabella", n. 498/499, Anno XLVIII, gennaio-febbraio 1984.
10 - L'assenza dell'industrial design nella mostra non dipende certo da scarsità ma dall'eccesso di esempi e ricerche sull'argomento, già abbondantemente indagato e documentato. Citiamo un unico testo proprio perché si colloca al limite della sua disciplina: D. Pario Perra, Low Cost Design, Silvana Edtoriale, Milano 2010.
11 - G. Adamson, J. Pavitt (a cura di), Postmodernism: Style and Subversion, 1970-1990, catalogo della mostra omonima, victoria &Albert Museum. 24.09.11 - 15.01.12, Londra 2011
12 - R. Martin, Utopia's Ghost: Architecture and Postmodernism, Again, University of Minnesota Press. 2010, p. XIII.
13 - Dal testo del brano dei New Order Bizarre Love Triangle (1986).
14 - La discussione che si è accesa di recente sulla "ritorno alla realtà" in vista di un grande convegno da tenersi a Bonn nel 2012 (interventi di Ferraris, Eco, Vattimo, Severino e molti altri) fa una strana impressione di sfalsamento temporale - sembra di tornare per un attimo alla prima versione di "Alfabeta" - ed è per buona parte imputabile a quella stessa nostalgia del moderno e della coscienza collettiva che Celant ben sintetizza. C'è però un aspetto interessante nel tema, soprattutto per quel che riguarda la concretezza dell'oggetto e l'idea di ripartire dal dato reale. Tutti concetti, mutatis mutandis, che finiscono per confermarci l'opportunità di questa mostra. Sull'argomento v. anche il testo di S. Marini pubblicato in questo catalogo.
15 - "Quello che è successo negli ultimi trent'anni è un'estrema 'personalizzazione' della ricerca, vale a dire la scomparsa di ogni lavoro di gruppo e la relativa sovraesposizione del soggetto e dell'artista singolo", in G. Celant, Arte Povera Stona e Stone, Electa, Milano 2011, p. 12. Per quel che riguarda lo stesso fenomeno in architettura v. P Ciorra, Senza architettura. Le ragioni di una crisi, Laterza. Roma-Bari 2011, p. 12.
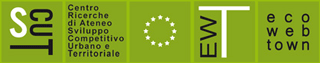 |
EWT/ EcoWebTown |





