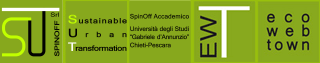Storia e progetto per Manieri Elia
María Margarita Segarra Lagunes
Storia e progetto: sono i due termini che spiccano, con la maggiore considerazione, nei due testi di Mario Manieri Elia che qui vengono ripubblicati. Un binomio che ha accompagnato la sua riflessione per molti decenni, tornando reiteratamente sia nei diversi numeri di “Topos e Progetto”, che nelle lezioni del Master da lui fondato “Architettura | Storia | Progetto”, o ancora nel suo lavoro come progettista (per esempio, per il concorso per Piazza Augusto Imperatore). Due assiomi ineludibili, utilizzati senza dogmatismi né preconcetti, come base su cui impostare qualsiasi discussione inerente l’intervento sul costruito storico esistente. Per i Fori Imperiali, più che mai. Il primo testo fu redatto nel corso della campagna di scavi avviata in vista del Giubileo del 2000, quando arrivò all’Amministrazione comunale un cospicuo finanziamento per la sistemazione e l’indagine archeologica del complesso forense, in vista del grande evento religioso che avrebbe coinvolto Roma da lì a poco. È un testo pieno di fiducia e di speranza, su cui Manieri Elia depositava la certezza che un palinsesto, come quello di cui si tratta, meritasse la massima attenzione, il maggiore impegno, la collaborazione di un’équipe multidisciplinare capace di condurre l’operazione al massimo livello di progettualità. Un testo in cui, come si è detto, la Storia è la protagonista indiscussa: quegli strati sovrapposti che nei secoli si erano depositati in quell’area e che si erano guadagnati, a pieno titolo, un riconoscimento per entrare a far parte di una scena urbana composita e talvolta contraddittoria, ma indiscutibilmente ricca e plurale. Una scena capace di narrare la complessità delle vicende di Roma, i suoi momenti aulici ma anche quelli oscuri e tragici. Un palinsesto che poteva, forse per la prima volta al mondo, farsi carico di colmare quella distanza, temporale ma anche fisica, che separa il contemporaneo dall’antico, arrestando «la vecchia, tradizionale idea di una restituzione alla vista della sequenza mitica delle grandi piazze imperiali», per dare spazio e voce alla Storia, a quei «lacerti di strutture tardoantiche ed altomedievali», a «un palazzetto porticato risalente alla Rinascenza carolingia», ai «copiosi resti residenziali e cultuali cinquecenteschi e barocchi», riapparsi in «un montaggio paradossale che pone gli elementi post-antichi, nell’ampia cadenza imperiale degli spazi, in una relazione complessa e in più luoghi con-fusa; ma necessaria e meravigliosa: storica, appunto». Quei resti che egli corse entusiasta a vedere e a fotografare non appena fu data la notizia del loro rinvenimento. L’entusiasmo era però supportato da un’altra convinzione: che fosse tramontata l’era degli scavi selettivi, quelli che essendosi prefissi un obiettivo, erano stati in grado di distruggere un intero quartiere post-antico, per portare alla luce le grandi piazze imperiali. E il ragionamento valeva anche per via dei Fori Imperiali, quell’asse che egli definiva «il più forte segno lasciato sulla città dal fascismo», che rischiava (e forse rischia tuttora) di diventare una «passerella», se non di scomparire del tutto, qualora il progetto di riunire i Fori con il Foro dovesse ancora andare avanti, senza tener conto del cambiamento che quel «segno fascista» ha acquisito negli ultimi settant’anni, diventando passeggiata domenicale, scenario di concerti e spettacoli, luogo di manifestazioni per la pace, per le donne, per tante battaglie civili che nel nostro mondo contemporaneo si combattono ogni giorno. Uno spazio pubblico a tutti gli effetti, utilizzato non solo da turisti ma dai romani, dagli abitanti che lì possono spendere una mattinata, anche semplicemente per passeggiare, per partecipare alla maratona o per il raduno delle biciclette.
Nel secondo saggio, Manieri, sempre agguerrito e insoddisfatto per l’andamento degli eventi, torna alla carica. Lo stato delle cose è mutato rispetto a quello del 1997: ormai lo scavo è stato compiuto. Forse i suoi appelli hanno avuto qualche effetto sugli archeologi che conducevano l’operazione, o forse semplicemente essi si sono convinti che dell’assetto forense imperiale quel che meritava di essere portato alla luce era già stato sistemato e valorizzato negli anni Trenta. Infatti, lo scavo ha risparmiato le cantine degli edifici barocchi, alcuni tratti di pavimentazioni maiolicate, le cucine dell’inizio del Novecento. Ma, a questo punto, mancava il secondo degli assiomi: quello attinente al progetto, agli obiettivi di quell’operazione: «l’incomprensione o il rifiuto di questa storia», scriveva Manieri nel 2000, «hanno portato alle polemiche senza sbocco di questi vent’anni, ad una ‘babele’ di linguaggi più ideologici che tecnici in cui, soccombendo la consapevolezza storica ed in mancanza di obiettivi di per sé sufficientemente chiari da parte dei fautori di una interpretazione fondata sulla complessità dei processi reali, non poteva che emergere e prevalere la cosiddetta priorità archeologica». Il risultato era lì, alla vista di tutti: un’area – una delle aree archeologiche più significative al mondo – rimasta incompiuta e incomprensibile, metodologicamente – e correttamente – sottesa «dal teorema: prima conoscere e poi progettare», ma, in realtà sorretta da «una logica, quest’ultima, la cui apparente linearità nasconde il reale significato di un programma che, per l’archeologia urbana, spesso significa semplicemente: prima distruggere l’esistente e poi progettare». E il sito resta incomprensibile ancora oggi, perché ciò che è mancato è il progetto, affidato a scelte casuali e banali, incapaci di esprimere efficacemente quel meraviglioso racconto di storia urbana che Manieri tanto auspicava. Per chiudere questo breve commento, nulla di più appropriato che le sue parole, valide ora come allora: «oggi, di fronte a una situazione assolutamente insoddisfacente, che ci presenta un campo di battaglia solcato da una rete ossessiva di recinzioni, dobbiamo riaprire il problema esattamente dal passaggio obbligato che a suo tempo è stato omesso: il progetto. Progetto in senso proprio: come sistema di decisioni scaturite dalla comprensione della situazione reale, intesa nella effettività del suo assetto plurale e mutevole, e dalla elaborazione del rapporto storico e attuale tra gli uomini e la realtà storica, colta sia nella sua materialità stratificata che nei suoi valori immateriali, insiti anche nelle dinamiche del suo divenire».
La costruzione di un progetto per l’area dei Fori Imperiali
Mario Manieri Elia*
Già Ordinario di Storia dell'Architettura, Università Roma Tre
Lo scavo del Foro di Nerva segna forse, finalmente, una ineludibile svolta riguardo al vecchio dibattito sulla sistemazione definitiva dell’area dei Fori Imperiali. Chi osservi i suoi impressionanti esiti e ne comprenda, senza pregiudizi, il senso, non può più nutrire dubbi sul percorso progettuale che dovrà essere imboccato; e ormai senza incertezze. Di fronte al composito palinsesto, così vivo nella sua autenticità storica emerso alla luce della contemporaneità, la vecchia, tradizionale idea di una restituzione alla vista della sequenza mitica delle grandi piazze imperiali, spogliate dall’ingombro della stratificazione storica successiva ed esposte, in un loro recuperato splendore come antologia monumentale dell’antica Roma, mostra ormai tutta la sua impossibilità; per non dire la sua ingenuità riduttiva.
Dopo i lavori di scavo eseguiti, stavolta, con mentalità e tecniche scientificamente aggiornate, l’immenso invaso dell’antico Foro Transitorio, sta lì a rappresentarci, ancora, la gigantesca dimensione aulica e classica del potere e dell’orgoglio di un impero tuttora in grado di pensare in grande, scotomizzando le incrinature dei dubbi sull’aeternitas di Roma; ma delle antiche membrature architettoniche – al di là delle due ‘Colonnacce’, da sempre esposte alla vista in una città in continua trasformazione – è rimasto così poco, da togliere dalla testa a chiunque, per questo come per gli altri Fori ancora sepolti, l’idea ottocentesca di ‘ liberare’ l’antico dalle stratificazioni successive.
Lo scavo, infatti, ha dato i suoi frutti, e nel modo migliore: ciò che è emerso, e che nessuno potrà più permettersi di ignorare o svalutare è, si può ben dire, la Storia. Lacerti di strutture tardoantiche ed altomedievali, un palazzetto porticato risalente alla Rinascenza carolingia, copiosi resti residenziali e cultuali cinquecenteschi e barocchi, in un montaggio paradossale che pone gli elementi post-antichi, nell’ampia cadenza imperiale degli spazi, in una relazione complessa e in più luoghi con-fusa; ma necessaria e meravigliosa: storica, appunto.
Disseppellendo questo straordinario patrimonio, lo scavo ha sepolto le vecchie concezioni selettivamente archeologistiche o antiquarie, confermando e rilanciando la priorità della memoria. Una memoria panica, da cui l’uomo contemporaneo non può più prescindere e che Sciascia definì «la nostra religione». È la coscienza dell’attualità di un passato che si estende fino alle vicende prossime; quelle da noi vissute e, in questo caso, con intensità. Non mi stancherò di richiamare, contro le facili condanne fondamentaliste che hanno colpito lo “stradone fascista”, quanto quella strada – già teatro notturno, illuminato lugubremente dai tripodi di cartone, del corteo di Mussolini e Hitler – abbia poi ospitato, ormai da mezzo secolo, ben diverse marce di lavoratori e studenti, per la libertà, per la pace; e poi, in più occasioni, sia divenuta spazio ludico, ampio e pedonalizzato, ad accogliere gioiosamente i cittadini romani in una passeggiata spettacolare, all’ombra delle grandi alberature, quei pini ancora urbani ma già agganciati alla sequenza verde che si estende verso il parco dell’Appia Antica, preannunciando i Castelli romani. Chi li baratterebbe a cuor leggero e senza una serissima e discussa motivazione, per qualche spazio in più di suolo archeologico da aggiungere agli ettari già scavati?
Ed ecco che, nello straordinario piano di sistemazione che siamo chiamati a produrre in un impegno corale e scomplessato di scienza urbana e di creatività progettuale, avremo bensì le spettacolari distese forensi, uniche al mondo ed i sopravvissuti resti marmorei della cultura classico-imperiale; ma questo contesto, perduta ogni rigidità selettivamente documentaria, risulterà umanizzato dall’essere flagrantemente compromesso con le dimensioni domestiche medievali e, più in su, con i tracciati stradali del nuovo quartiere cinquecentesco voluto da Pio V e dal cardinale Alessandro Bonelli, di cui restano case e monumenti, demoliti fino alla quota stradale dagli ingegneri fascisti. Ma, oltre a tutto ciò, nel montaggio dello smisurato palinsesto storico, il grande progetto che abbiamo finalmente avviato dovrà anche lasciare al godimento dei cittadini alcuni significativi brani della Roma contemporanea; e non, come qualcuno ha proposto, solo la carreggiata tesa tra Palazzo Venezia e il Colosseo: quest’ultima, che rappresenta il più forte segno lasciato sulla città dal fascismo, non può essere ridotta a passerella, in equilibrio su un artificioso panorama forense ruderizzato. Ove non in contrasto con i maggiori reperti oggi sepolti, saranno lasciati, a memoria della sistemazione che tutti abbiamo vissuto da quando eravamo bambini, almeno una parte significativa degli ampi marciapiedi, dei giardini e delle splendide alberature. Soprattutto, dovranno essere conservati e resi riconoscibili i principali tracciati cinquecenteschi, a partire dalla croce di strade Alessandrina e Bonella, recuperati nella loro giacitura originaria e nei fiancheggianti resti del contesto edilizio bonelliano.
È un progetto difficile, da attuare nel tempo, che senza smorzare la vitalità di un pezzo di Roma tra i più belli, mira a rendere fruibile, spettacolare e parlante il più straordinario patrimonio di documentazione storica dell’Occidente: a riconoscimento delle vicende del nostro passato, in tutta la loro irriducibile edificante complessità.
In: “Quaderni ARCo. Restauro Storia Tecnica, Gangemi, Roma 1997, pp. 17-18.
Area dei Fori: una doppia ‘ipertrofia storica’
Mario Manieri Elia *
Già Ordinario di Storia dell'Architettura, Università Roma Tre
Non tutti ce ne rendiamo conto: ma sono due, e ben distinte, ancorché in parte coincidenti, le storie che si sovrappongono nell’area dei Fori Imperiali. Vi è una Storia con la S maiuscola, inchiodata all’idea della Città Aeterna, secondo un rituale agiografico mobilitato da due millenni, usato politicamente almeno da due secoli e al centro di un lacerante dibattito culturale da più di due decenni; e c’è, accanto od attorno ad essa ma in opposizione dialettica, un’altra storia, fatta di contrasti e talora di malintesi, soprattutto di grandi tensioni proporzionate alla potenza affermativa della prima. E questa seconda è la storia di una lunga evoluzione urbana che precede, accompagna e segue la roboante sequenza di interventi monumentali che, in poco più di un secolo, hanno imposto alla città i luoghi della propria autocelebrazione di caput mundi.
Delle due storie, la prima ci tramanda con forza egemonica il proprio mito, eternato nella sua pietrificazione monumentale. La seconda raccoglie, invece, le testimonianze di una travagliata vicenda reale, fatta di uomini e di donne nel territorio urbano, del loro adattarsi all’ambiente adattandolo al proprio modo di abitarlo. Una storia lunga e accidentata, attraversata dalla repentina, smisurata sequenza di interventi di monumentalizzazione che si son fatti largo nell’abitato; seguiti, nella sopravvenuta stasi colma di attesa, dal lento processo di de-monumentalizzazione e di ritorno alla naturalità di una evoluzione urbana discontinua e mutevole, comunque vitale e preziosa nel suo aderire alla varietà sanguigna delle vicende umane. E sono, in definitiva, due storie che, in realtà, possiamo riconoscere e confrontare in tutti i contesti, le quali però, a Roma, capitale del mondo pagano e del suo opposto, perno storico tra Oriente ed Occidente, si confrontano esemplarmente ai massimi livelli ideologici e concettuali.
La nostra costante attenzione alla storia – attenzione che Nietzsche qualifica criticamente come ‘virtù ipertrofica’, per il suo condizionare il pensiero degli uomini bloccandone l’iniziativa – qui, insomma, nell’area dei Fori Imperiali deve sdoppiarsi; e in modo più divaricato e clamoroso che altrove. Chi è sedotto dal grande modello, massima autorappresentazione di un potere unico al mondo, ha scelto il mito: l’allegoria soprastorica di una centralità planetaria di Roma. Chi, invece, si sente impegnato anche dalla complessità di una storia le cui tracce e memorie pre e post-antiche, ancorché meno clamorose ma di flagrante autenticità storica, permeano profondamente il luogo, aderendo alla pluralità delle vicende umane, pretende di cogliere lo spirito del sito, teatro di un confronto oppositivo tra Permanente e Divenire. Uno scontro, insomma, che ne costituisce il senso più reale: il Genius loci.
A ben vedere, è proprio il mancato chiarimento tra le due letture ad aver sempre generato confusione e radicalità oppositiva. Tuttora, del resto, assistiamo al faticoso, vacillante dibattito che divide convinzioni ed intenzioni diverse, non di rado inconsapevoli della loro stessa contrapposizione ideologica di base. Ma è un dibattito che ha radici antiche. Se si rileggono i sacri testi degli anni Cinquanta e Sessanta, riguardanti la via dei Fori Imperiali (Cederna, Benevolo, Insolera), testi sui quali si è formata la generazione militante nelle polemiche di vent’anni fa (dominate a livello istituzionale dalla figura ‘eroica’ di Adriano La Regina), la storia urbana ne esce riassunta in schemi a dir poco paradossali. Secondo quei testi, fondamentalisti nell’avversione all’assetto conferito all’area durante il fascismo, la trasformazione del sito sarebbe stata orientata da due obiettivi posti in necessaria successione e tuttavia palesemente contraddittori tra loro: scavare tutto e subito, alla ricerca dell’integrità del contesto monumentale forense, a prezzo di un immane sventramento che elimina un intero quartiere della città storica senza alcuna ricostruzione; e, poco dopo, ricoprire e nascondere una notevole parte delle fastose piazze imperiali riscoperte, realizzandovi sopra una larga e lunghissima piattaforma stradale con annessi giardinetti d’epoca.
Naturalmente la logica del programma non era così aberrante: tutt’altro. La contraddizione, in gran parte apparente, nasceva dalla tensione ossessiva per un rapporto storico di natura ambivalente, perché diviso tra la tendenza a riscoprire le tracce monumentali di un glorioso passato, offuscate da secoli di mediocre vita urbana da scotomizzare e, in definitiva, da cancellare; e l’ambizioso orgoglio di identificarsi direttamente con tale assetto mitico, interpretandone il valore icastico e identificandosi con esso, nella nuova sistemazione, apodittica ma coerente, di via dell’Impero.
In realtà, scrupolosi studi precedenti e concomitanti all’intervento degli anni Trenta, avevano già documentato l’esistenza, in situ, di ampie e significative preesistenze ipogee medievali, rinascimentali e barocche, concresciute nelle amplissime lacune lasciate nella discontinua compagine dell’architettura imperiale da una attività millenaria di spoglio sistematico. Non a caso, gli scavi del Foro di Nerva, precedenti alla più recente campagna archeologica nei Fori di Cesare e di Traiano, hanno rivelato la pressoché totale assenza di reperti litici antichi; salvo che per le due colonne che hanno attraversato – esposte e denominate simpaticamente ‘le Colonnacce’–, la lunghissima vicenda della desimbolizzazione. Bastava questo, per chiudere il vecchio, a tratti risorgente discorso, orientato al recupero delle ‘Piazze Imperiali’, per affrontare il grande, ineludibile problema di scienza urbana che la riprogettazione del sito impone all’affascinata attenzione del mondo.
Un’intrigante, mutevole vicenda che, dall’insediarsi delle prime case e chiesette – come quella di San Nicolao ad Columna, che adoperò come campanile la Colonna Traiana – all’uso come palcoscenico dei Mercati Traianei da parte dei poeti umanisti; alla bonelliana croce di strade, che, urbanizzando l’area, nascose temporaneamente le vestigia del mito nelle cantine dell’abitato; fino alle plurivalenti (tra identificazione, emulazione e modernizzazione) trasformazioni fasciste, ha visto la città rinnovare i riti presupposti dal Genius loci: il travagliato, interminabile confronto, cioè, della città con il proprio mito.
L’incomprensione o il rifiuto di questa storia hanno portato alle polemiche senza sbocco di questi vent’anni: ad una ‘babele’ di linguaggi più ideologici che tecnici in cui, soccombendo la consapevolezza storica ed in mancanza di obiettivi di per sé sufficientemente chiari da parte dei fautori di una interpretazione fondata sulla complessità dei processi reali, non poteva che emergere e prevalere la cosiddetta priorità archeologica. Partiva così tre anni fa, con una dote di finanziamenti una volta tanto adeguati, una iniziativa – gestita dalla Sovraintendenza comunale (guidata da un archeologo) e sotto la diretta autorità della Soprintendenza di Stato (un altro archeologo) – una iniziativa finalizzata ad un ampio programma di scavi, legittimato metodologicamente dal teorema: prima conoscere e poi progettare. Una logica, quest’ultima, la cui apparente linearità nasconde il reale significato di un programma che, per l’archeologia urbana, spesso significa semplicemente: prima distruggere l’esistente e poi progettare. Che tuttavia, proponendosi con immediata quanto fuorviante evidenza non poteva non convincere, subito, buona parte dei nostri politici e della stampa.
Così, un contesto urbano tra i più formidabili del mondo – quello determinato dalla sistemazione degli anni Trenta, poi consolidatosi come asse d’innesto alla città del parco dell’Appia Antica e di lancio di un vettore urbano veloce verso il nuovo Foro dell’E42 e verso il mare – viene investito da un processo di trasformazione senza progetto, nel quale tutto ciò che appartiene alla copiosa stratificazione postantica può essere eliminato prima ancora che esista un disegno complessivo entro il quale l’eliminazione stessa abbia un senso. Un intervento, quindi, inibito a porsi come fase di una evoluzione, salvo che nella direzione della restituzione – peraltro impossibile, come gli scavi stessi hanno ulteriormente dimostrato – dell’assetto forense imperiale.
Oggi, di fronte a una situazione assolutamente insoddisfacente, che ci presenta un campo di battaglia solcato da una rete ossessiva di recinzioni dobbiamo riaprire il problema esattamente dal passaggio obbligato che a suo tempo è stato omesso: il progetto. Progetto in senso proprio: come sistema di decisioni scaturite dalla comprensione della situazione reale, intesa nella effettività del suo assetto plurale e mutevole, e dalla elaborazione del rapporto storico e attuale tra gli uomini e la realtà storica, colta sia nella sua materialità stratificata che nei suoi valori immateriali, insiti anche nelle dinamiche del suo divenire.
Ogni scorciatoia – come il proporre lo strumento concorsuale – e ogni settorialità – come l’avvio di processi decisionali affidati a un solo aspetto: quello archeologico, o quello della mobilità, o quello ambientalistico, ecc. – comportano null’altro che nuove illusioni decisioniste ed effettivi sprechi e ritardi. Bisogna ripartire dalla conoscenza, facendo bensì tesoro delle nuove acquisizioni archeologiche, alla luce delle quali, però, rivedere anche le vecchie acquisizioni archiviate e spesso dimenticate. Ma infine occorre sviluppare finalmente quei processi collettivi d’indagine e di valutazione intersettoriali, che mobilitino finalmente tutte le potenzialità investigative e creative della scienza urbana e della progettazione contemporanea.
in: Atti del IV Convegno Nazionale ARCo Manutenzione e recupero nella Città storica, L’inserzione del nuovo nel vecchio a trenta anni da Cesare Brandi, Gangemi, Roma 2002, pp. 27-32.