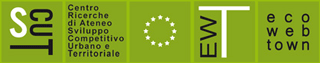Mario Cucinella MCArchitects_IUAV Venezia |
 |
Designing Eco-town
Convegno internazionale
12-13 maggio 2010
Facoltà di architettura, Università di Pescara
La sostenibilità in architettura dovrebbe riconsiderare i fattori sensibili ed emotivi come linee guida dei processi: dovremmo riflettere più che sugli aspetti normativi, altrettanto importanti ma che hanno un approccio troppo tecnico, su aspetti più sensitivi, che forse la cultura della tecnologia ci fa sfuggire.
Alla scala urbana non è sempre facile trovare esempi di come mettere insieme i nostri edifici, sapendo che quando parliamo di struttura delle città il nostro territorio ha caratteri peculiari e diversi per esempio dalla Cina dove si costruisce ragionando in termini quantitativi; noi abbiamo bisogno di cambiare attitudine, dovremmo completare le nostre città con una visione organica; non costruire città nuove ma intervenire chirurgicamente sulla città esistente per produrre emozioni, qualità, relazioni sociali, tutte cose che non sono scritte in nessuna norma. La crisi più evidente in tal senso è legata al fatto di aver compreso che la norma non produce bellezza, regola ma non crea bellezza: bisognerebbe ragionare su cosa significhi produrre un sistema burocratico così complesso che non costruisca qualcosa di cui essere fieri, bisognerebbe mettere in discussione la modalità stessa di pensiero.
Il caso del giardino tropicale di Garnish Island a Cork in Irlanda aiuta a cambiare modalità di pensiero. Si fonda sul concetto di empatia preventiva. E’ una storia che racconta di un'isola di roccia che nel 1900 viene acquistata da un generale inglese che, con un amico paesaggista, decide di trasformarla in un giardino botanico. Loro avevano capito qualcosa che era in nuce, benché all'inizio fosse una terra inospitale. Il paesaggista aveva compreso che piantare dei cespugli avrebbe modificato l'andamento dei venti e riparato il suolo dalle piogge; ciò avrebbe creato le condizioni per far crescere le piante più robuste lavorando lentamente in un processo di azione e reazione. Dopo 30 anni quell'isola è diventata un giardino. Nel progetto sono stati determinanti il fattore tempo e la relazione con l'ambiente. Oggi questo giardino ha 10000 specie di piante, fiori, 250000 visitatori l'anno.
Il fattore tempo è determinante per il successo delle politiche ambientali. Abbiamo strumenti che ci permettono di analizzare ogni cosa e, in maniera chirurgica, apportare modifiche per raggiungere obiettivi come la riduzione del 20% delle emissioni di CO2. Tali obiettivi non hanno solo carattere prestazionale, quantitativo, non significano solo usare le rinnovabili e la tecnologia, ma servono a salvaguardare la vita dell’uomo. Il fine ultimo è il miglioramento della vita sul pianeta.
L'esperienza vissuta nelle nostre città, e questo l'abbiamo capito ancora di più lavorando a L'Aquila, ci dice quanto la città storica abbia un valore straordinario come luogo della socialità e della memoria, senza il quale la realtà urbana degli ultimi 30 anni diviene invivibile, evidenziando quanto sia importante recuperare questa sensibilità, questo aspetto interiore.
Oggi la geografia dei consumi, della produzione di energia elettrica, appare profondamente diversa rispetto alla localizzazione geografica; L'Italia è un paese che vive troppo di dipendenza dal petrolio, la Germania ha fatto viceversa una politica sulle fonti rinnovabili straordinaria. Abbiamo un problema concreto che se da una parte offre un'opportunità di qualità e bellezza dall'altro apre scenari contrastanti. Ci sono tanti elementi per poter mettere in pratica la conservazione dell'energia eppure il nucleare assorbe l'80% dei finanziamenti per la ricerca scientifica. Se si pilotasse solo il 30% della ricerca sulle rinnovabili probabilmente in 10 anni il mondo sarebbe rivoluzionato.
Se il tema della sostenibilità oggi interessa gli architetti di tutto il pianeta, è pur vero che la domanda di energia negli ultimi anni è cresciuta, tanto che non sappiamo più come fare ad alimentare questa macchina. Nel trend degli ultimi 40 anni non siamo andati verso la direzione del rigore, ma del consumo e continuiamo a crescere. In uno scenario come questo noi siamo gli attori del cambiamento, perché l'edilizia consuma il 50% di tutte le risorse energetiche. Poiché il tema dei consumi è legato agli stili di vita, non è solo un problema di quantità: se vivessimo tutti come gli americani avremmo bisogno di 5 pianeti, se vivessimo come gli inglesi avremmo bisogno di 3 pianeti, potremmo introdurre tutte le norme possibili senza soluzione.
Il futuro dell'architettura è a mio avviso in un’immagine che rappresenta un medico su un cammello: il medico ha un palmare in tasca per trovare la strada, sulla testa il cammello ha un'antenna gps e sulla gobba un pannello fotovoltaico che alimenta una batteria che fa funzionare un frigorifero in cui ci sono le medicine. L'immagine rappresenta una visione: l'architettura che faremo è quella in cui la tecnologia sarà un aspetto marginale: ci aiuterà, ma il contenuto fondamentale sarà la forma, la materia, la modalità, l'intelligenza e i processi creativi che ci permetteranno di fare architettura come abbiamo fatto per millenni. L'elettricità nei nostri edifici c'è da 150 anni, il riscaldamento da 60, per 2000 anni abbiamo costruito dove non c'era niente, dietro di noi abbiamo un back ground di conoscenze; poi abbiamo vissuto un momento in cui ci siamo distratti, abbiamo pensato che gli edifici li facesse qualcun altro e adesso stiamo pensando che forse bisogna ricominciare a fare gli architetti.
Io credo che l'innovazione non sia tanto sulla tecnologia ma sulla conoscenza, noi saremo capaci di progettare edifici senza energia e la tecnologia sarà sulla materia, c'è un'enorme evoluzione sulle capacità dei materiali di comportarsi, di reagire, di assorbire, di selezionare; avremo anche punte di diamante che saranno il fotovoltaico di nuova generazione, il solare termico, l'idrogeno.
Questo è il tema su cui provo a lavorare: il rapporto tra sostenibilità e architettura rappresenta una grande opportunità creativa. Riprendere il ruolo fondamentale che gli architetti hanno avuto nella storia, lavorare sugli edifici e la forma, coscienti di non poter più dissociare l’ambiente dall’architettura crea una nuova etica .
Mario Cucinella si forma con Giancarlo De Carlo, lavora per 5 anni allo studio di Renzo Piano, fonda nel 1992 a Parigi la società Mario Cucinella Architects. Il suo studio oggi ha sede a Bologna ed il suo lavoro si concentra sulla tecnologia che è introiettata nel processo di costruzione della forma.